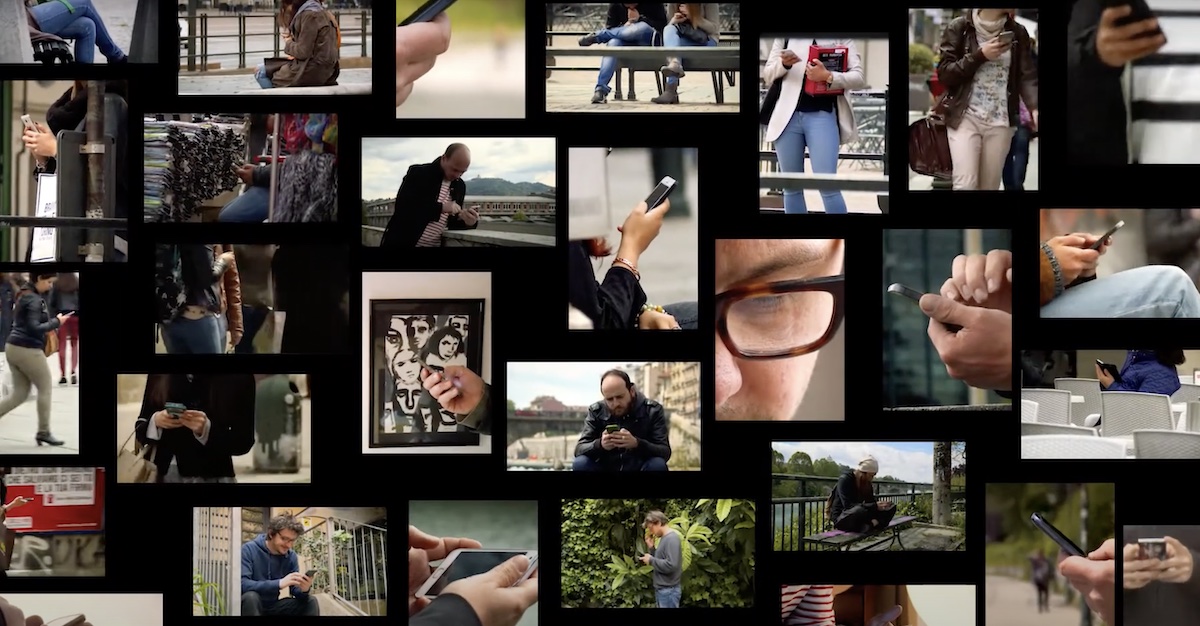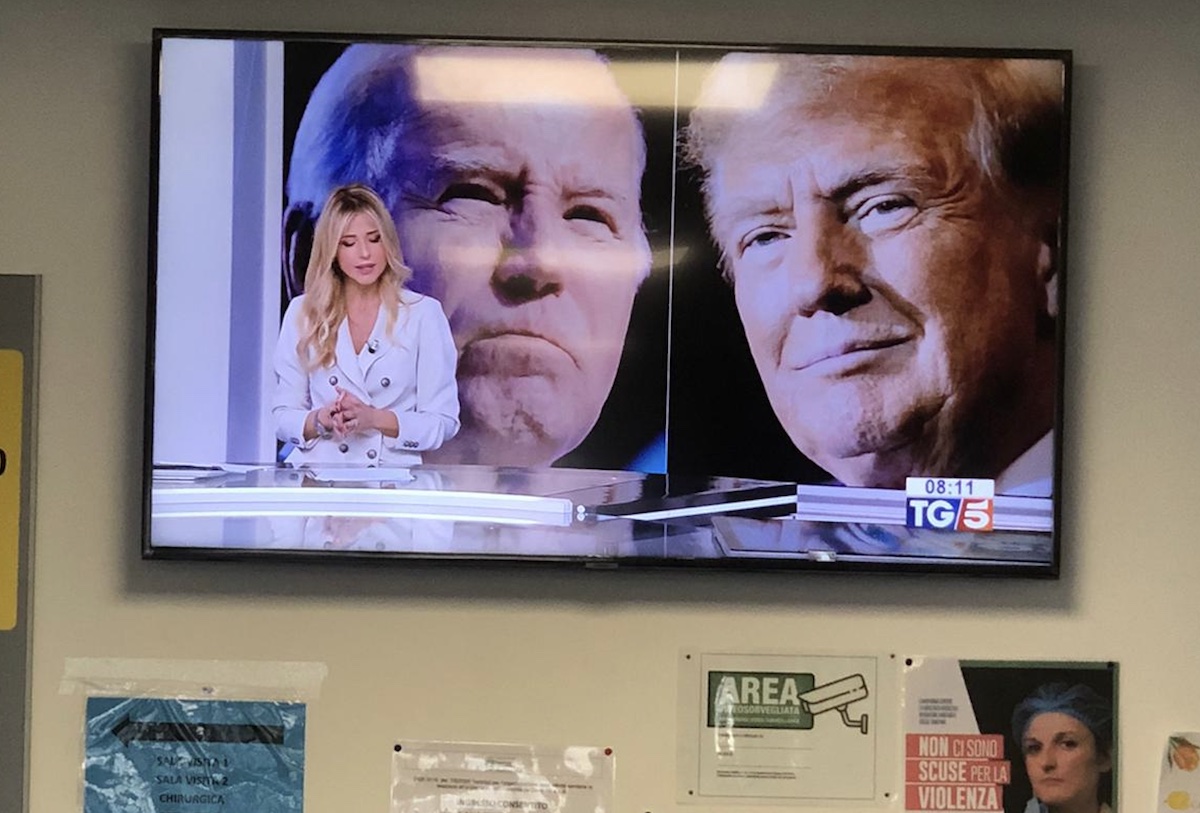In Italia, il giornalismo non è certo il luogo della diversità e della varietà. Anzi. Per dirla con una battuta che ormai dico spesso e che purtroppo è sempre amaramente attuale, il giornalismo italiano è a forma di maschio bianco autoritario, paternalista, benestante, over 50, eterosessuale.
Dove sono i grandi giornali diretti da donne, per esempio? E dove sono le storie che raccontano diversi punti di vista che siano di genere, di etnia, di orientamento sessuale ed affettivo, di generazioni, di differenti abilità, di differenti capacità di spesa, di censo? Sono poche, pochissime. E spesso sono raccontate dal punto di vista dominante.
Tra queste poche, pochissime cose, in Italia esiste dal 2016 un premio che si chiama Diversity Awards, che viene assegnato anche ad articoli di giornale che si sono particolarmente distinti sul tema. È un piccolo passo, ma il tema – fatte salve poche, lodevoli eccezioni – è il grande assente dai tanti dibattiti che si svolgono a proposito del giornalismo italiano.
Il fatto è che questo concetto, la diversity, in Italia sembra proprio non riuscire a farsi strada, sepolto da soluzioni riduzioniste – ancorché necessarie – come le quote rosa e da obiezioni altrettanto riduzioniste del tipo: «vabbe’, ma conta il merito, non essere uomo o donna».
Come se la rappresentazione e l’inclusione della diversità fossero un problema semplice.
Nel 2017 il Diversity & Inclusion Manager di TIM scriveva un pezzo dal titolo Perché il Diversity Management non sta decollando in Italia? 10 risposte. Tra le sue risposte ce n’è una molto eloquente: «lo storytelling è ancora nel guado: se presente nelle comunicazioni interne dell’azienda e tra gli addetti ai lavori, è quasi totalmente assente nella narrazione più generale e mainstream. Le aziende sono narrate dai media ancora per le dimensioni finanziarie e commerciali, poco per quelle legate alle persone».
Questo richiama il giornalismo alle sue precise responsabilità sul tema.
D’altra parte, ci sono altre questioni che spaventano: nel 2018, per esempio, una ricerca della FNSI ha rivelato che l’85% delle giornaliste donne intervistate ha dichiarato di aver subito molestie sessuali in redazione.
E se apri un articolo di giornale in cui si parla di questioni che sono presuntamente “di genere”, come l’accudimento dei figli, o di gravi casi di cronaca come i femminicidi, ci trovi spesso un linguaggio, una forma di racconto, terminologie che finiscono per empatizzare con gli assassini. È un fatto.
Ci si trova ancora di fronte a titoli tipo: «Le mamme danesi contro la riapertura delle scuole». Leggiamo ancora frasi come: «probabilmente è stato quell’amore primitivo e morboso a far perdere la testa all’uomo incapace di assorbire l’ennesimo rifiuto» (su Repubblica, uno dei primi giornali italiani, in teoria afferente ad aree progressiste).
Non parliamo poi della rappresentanza per provenienza geografica: nelle redazioni italiane ci sono davvero pochi giornalisti stranieri, a fronte di una popolazione di cittadine e cittadini stranieri che nel 2018 superava i 5 milioni (fonte: LeNius)
«Non vi sono statistiche ufficiali», scrive Silvia Godano su Voci Globali, «ma è certo che si tratti di un numero piuttosto sparuto. Tra il 2016 e il 2017 sono andata a cercarli e ho condotto una serie di interviste per capire quali fossero le loro condizioni lavorative. Albania, Turchia, Romania, Algeria, Cile, Montenegro e Serbia: questi i Paesi da cui provenivano i nove giornalisti con cui ho parlato. Soltanto tre di loro erano iscritti all’albo dei giornalisti, di cui uno solo come professionista. I temi emersi dalle interviste sono la difficile cornice legislativa per i giornalisti stranieri in Italia, il lavoro nei cosiddetti media etnici e la tortuosa collaborazione con i media mainstream».
E la diversity è anche una questione di censo.
Viviamo in un mondo occidentale dove le istituzioni – dalla politica al giornalismo – si sono progressivamente staccate dalla realtà di massa. Persino quelle tradizionalmente vicine alle masse di chi ha meno. Come il partito Laburista nel Regno unito, per esempio: fino alla metà degli anni ’80 almeno un terzo dei suoi esponenti proveniva dalla cosiddetta working class. «Oggi – scrive Julia Cagè in Le prix de la démocratie – meno del 5% dei parlamentari nel Regno Unito e meno del 2% del congresso in USA (contro il 54% della popolazione attiva) viene dal mondo del lavoro manuale o in ufficio». Anche questa è assenza di diversity. Della peggior specie, perché evidentemente riguarda la rappresentanza democratica. L’esclusione, la derisione di chi si pone il problema del rappresentare le diversità, non fa che costruire un mondo a forma di chi ha di più.
E Slow News, allora?
Quando abbiamo deciso di fondare Slow News, in un bar di Milano, nel 2014, eravamo tutti maschi. Non è successo per scelta. È successo e basta. Era un momento complesso per molti di noi, e all’inizio di un percorso, se non ti trovi in un ambiente stimolante che ti aiuta a comprendere il valore della diversità anche solo nella composizione di un gruppo di lavoro, è sempre molto difficile capire.
Ma ci siamo posti da subito il problema, stimolati anche da un lavoro internazionale di 4 anni che ci ha portati a visitare più di una decina di redazioni, tra gli Stati Uniti e l’Europa, per realizzare un documentario che si intitola Slow News, come la nostra testata.
La domanda che ci siamo fatti è: come possiamo raccontare il mondo se siamo privi al nostro interno di punti di vista? Come fa una redazione a raccontare storie, se le guarda sempre dal proprio ombelico?
È per questo che, da sempre, siamo attenti a cercare persone diverse da noi a cui commissionare le nostre serie, per ampliare non solo le nostre vedute, ma anche il racconto del mondo che offriamo alle nostre lettrici e ai nostri lettori.
Nel corso degli anni abbiamo imparato che le azioni pesano più delle parole. Oltre ad arricchire la diversity della squadra di chi scrive per noi, abbiamo organizzato incontri e dibattiti, invitando a parlare ospiti importanti, internazionali, ma soprattutto donne tutte le volte che potevamo.
Durante il primo Slow News Day, nell’ottobre del 2019, per esempio, delle quattro persone che abbiamo invitato a parlare, tre erano donne: Helen Boaden (ex direttrice della BBC News), Irene Smit (direttrice di Flow) e Liliana Di Donati (caporedattrice news di Donna Moderna).
Anche davanti a loro, la maggior parte del pubblico era composto da donne. Tra loro, la prima delle donne che abbiamo coinvolto nei nostri progetti, Mafe De Baggis, che scrisse questo tweet:
Un editore #tuttimaschi mette sul palco #tuttedonne, è #SlowNewsDay, bellezza! @albertopi pic.twitter.com/RFT8hT3wFK
— mafe (@mafedebaggis) October 19, 2019
Oggi abbiamo una squadra di collaboratrici e collaboratori molto varia e bilanciata.
Ogni volta che l’italiano, lingua in cui predomina il maschile, ce lo consente, utilizziamo un linguaggio che all’estero definirebbero gender balanced.
Siamo solo all’inizio. Lavoriamo ogni giorno per includere all’interno della nostra squadra punti di vista che ancora ci mancano.
Procediamo per piccoli passi, con lentezza, perché siamo una piccola realtà e abbiamo forze limitate, ma sappiamo – lo abbiamo imparato – che non c’è alcun cambiamento che non si poggi su basi solide.
E, nel nostro piccolo, crediamo fortemente che sia fondamentale porci questo genere di problemi, anche se le realtà più grosse sembrano ignorarli completamente.