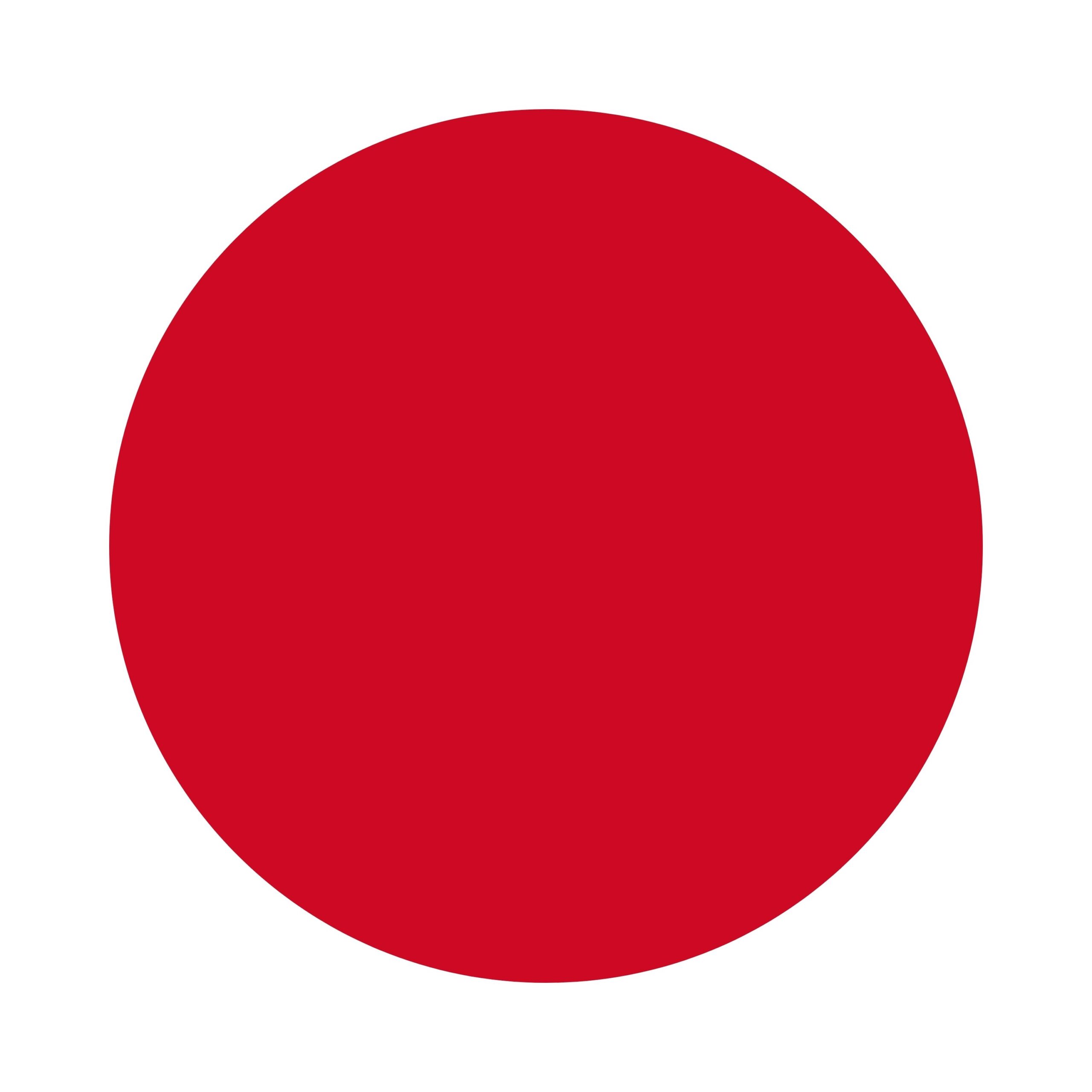Il Nord Stream è un gasdotto che, da novembre del 2011 fino a settembre del 2022, trasportava gas proveniente dalla Russia in Europa occidentale.
Il progetto nasceva già controverso per ragioni geopolitiche: rappresentava infatti un legame tra Russia e Unione Europea, con una proprietà condivisa tra cinque grandi aziende energetiche (il 51% alla russa Gazprom, poi le quattro europee Wintershall Dea, E.ON, Gasunie ed ENGIE).
A settembre 2022 sono state scoperte tre falle in due delle quattro tubature che compongono il gasdotto e che ne hanno interrotto la funzionalità. A novembre del 2022 si è confermata l’origine dolosa delle falle: esplosivo.
Le parti in causa (stati dell’Unione Europea, Russia, U.S.A., Ucraina) si sono rimbalzate la responsabilità ed è scoppiato, come al solito il tifo.
Il 28 ottobre 2022, il giornalista Stephen Kinzer ha scritto su Responsible Statecraft che «Il sabotaggio del Nord Stream è solo l’ultimo e il più spettacolare esempio di quanto siano vitali i gasdotti per la sicurezza politica ed economica di molte nazioni», ricordando anche vari casi di pressioni politiche per impedirne la realizzazione.
L’8 febbraio 2023 il giornalista investigativo americano Seymour Hersh ha pubblicato un lungo pezzo sul suo Substack, accusando la Casa Bianca di aver organizzato il sabotaggio con la collaborazione della Norvegia.
Il problema principale di quel pezzo è che si basa su un’unica fonte, non rivelata, descritta da Hersh come «fonte a conoscenza diretta del piano operativo» (la traduzione è mia). La Casa Bianca ha negato ogni responsabilità, così come il Ministero degli Esteri norvegese.
L’8 marzo 2023 il New York Times, citando fonti ufficiali U.S.A. e indagini dell’intelligence americana, ha pubblicato un pezzo che attribuisce il sabotaggio, genericamente, a gruppi pro-Ucraina, senza prove di un eventuale coinvolgimento del governo ucraino stesso.
La verità è ancora lontana. Ma questa storia ci insegna già qualcosa. Che non è il caso di tifare ciecamente, quando c’è una guerra che guardi relativamente da lontano. Che non è il caso di aggiungere opinioni alle opinioni. Che è il caso di attenersi ai fatti, e di raccontarli nella maniera più asettica possibile.