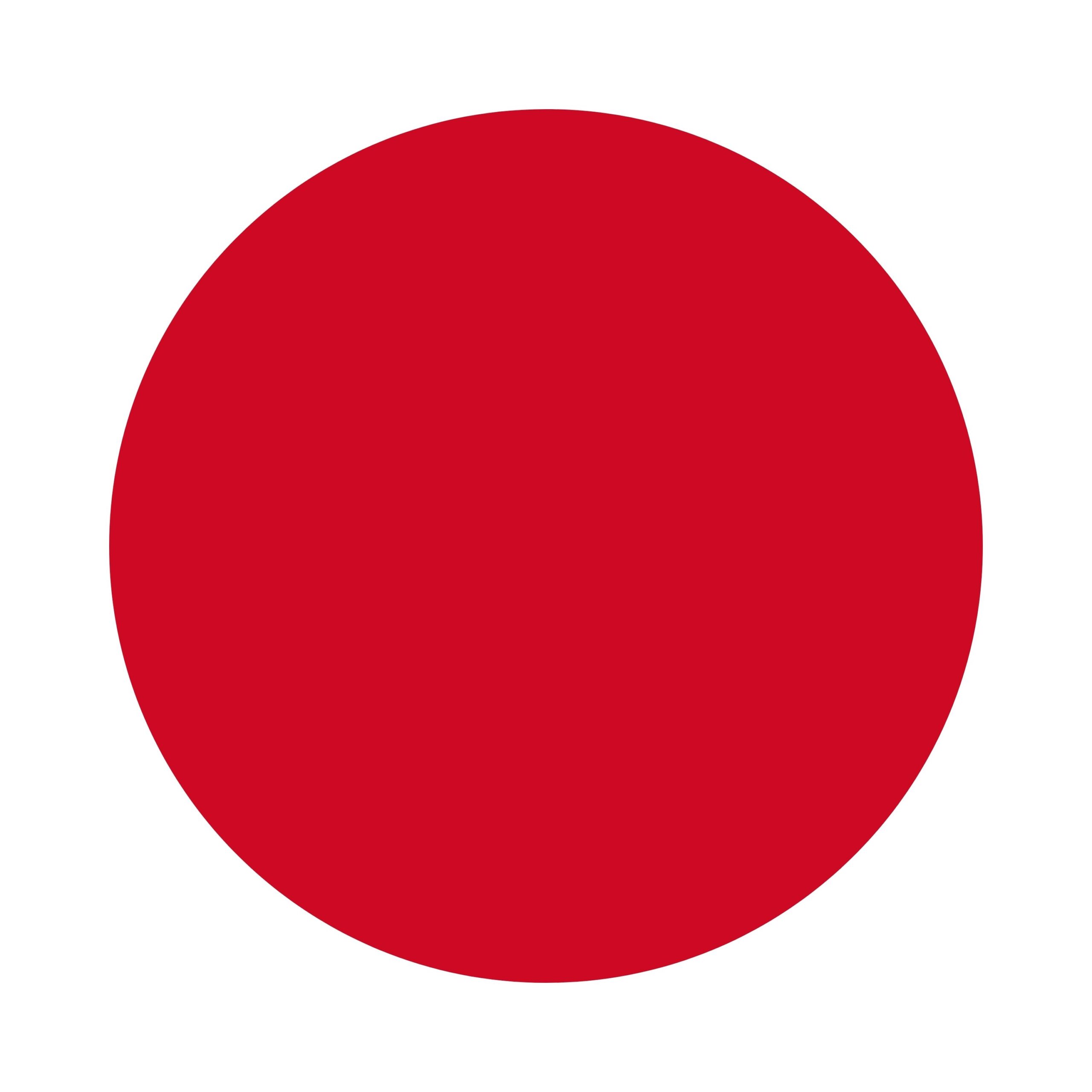Salmone, cozze, occhialone, trota arcobaleno, spigola, ostrica e carpa sono le specie ittiche prodotte in acquacoltura all’interno dell’Unione Europea, circa il 20% dell’approvvigionamento di pesce e crostacei nell’intera UE. Un settore che impiega direttamente 70.000 persone, distribuite in 15.000 micro e piccole imprese.
Il Green New Deal europeo riconosce l’acquacoltura come “fonte di proteine a basse emissioni di carbonio” per alimenti e mangimi, produzione che deve rispettare requisiti molto rigorosi per garantire che questa industria tuteli sia la salute umana che quella animale, oltre che l’ambiente.
La maggior parte dei mangimi che utilizziamo in Europa per l’acquacoltura viene prodotta fuori dall’UE e una massiccia percentuale arriva dall’Africa occidentale, dalle cui acque ogni anno vengono pescati mezzo milione di tonnellate di piccoli pesci pelagici, trasformati in mangimi (ma anche integratori, cosmetici e alimenti per animali domestici) destinati ai mercati extra-africani. Si tratta di quei pesci che, tipicamente, vengono pescati dai pescatori locali e rivenduti nei mercati locali e che oggi non solo non hanno (quasi) più niente da pescare: non hanno (quasi) più niente da vendere e (quasi) più niente da mangiare. I pesci pelagici vengono trasformati in farina e olio ed esportati in particolare in Europa e in Asia, dove vengono utilizzati per l’alimentazione degli animali da allevamento e dei voraci pesci d’acquacoltura: ogni anno vengono esportate dal solo Gambia circa 19.300 tonnellate di pesce attraverso le attività di fabbriche di farina di pesce, navi industriali straniere e imprese di lavorazione del pesce destinate ai mercati esteri.
Negli anni si sono moltiplicati i documenti che mostrano come l’acquacoltura europea sia estremamente sostenibile dentro le acque europee e, contemporaneamente, gravemente predatoria per gli stock ittici extra-europei. Questo rapporto pubblicato da Amnesty International alla fine di maggio racconta come l’eccessivo sfruttamento delle risorse ittiche a largo del Gambia e del Senegal stia impoverendo le (non più) abbondanti risorse ittiche di quelle acque: il settore della pesca rappresenta il 12% del PIL del Gambia e fornisce occupazione diretta e indiretta a oltre 300.000 persone, su una popolazione totale di 2,2 milioni di abitanti.
I pescatori si trovano spesso a competere con i grandi pescherecci stranieri che, a causa della mancanza di pattuglie sufficienti da parte della marina gambiana, si avvicinano alla costa più di quanto consentito, pescando in aree riservate ai pescatori artigianali. Queste pratiche sono illegali e queste navi depredano illegalmente le abbondanti risorse ittiche del Paese, causando gravi conseguenze sui mezzi di sussistenza della popolazione locale, la cui sopravvivenza dipende appunto dalla pesca: il pesce, che una volta forniva tra il 50 e il 60% del fabbisogno proteico animale dei gambiani, è sempre più raro e costoso sul mercato locale.