Le soluzioni degli altri
Venezia è unica. Ma non è l’unica. E non è sola.
Airbnb è anche, sulla carta almeno, una comunità. Ma cosa c’è veramente dietro la facciata del community-driven brand?

L’esperienza su Airbnb di John e Alice, la coppia di Glasgow che abbiamo incontrato nell’episodio precedente, non è la prima del genere. Qualche anno fa, usavano un’altra piattaforma: Couchsurfing. La usavano sia per ospitare che per essere ospitati durante i loro viaggi in giro per il mondo. Couchsurfing è una piattaforma di condivisione di ospitalità che ai tempi d’oro — tra il 2007 e il 2011 — era riuscita a creare una comunità liquida di viaggiatrici e viaggiatori da tutto il mondo che si scambiavano ospitalità senza scambiarsi un euro. Sono stati anni interessanti, concordano John e Alice.
L’esperimento di Couchsurfing sembrava funzionare. Attorno alla piattaforma si era effettivamente creata una comunità vera di persone, dal basso, persone che miglioravano la piattaforma, persino nel codice. Si formavano amicizie, si viaggiava da insider in qualsiasi luogo del mondo, e lo si faceva gratis, come gli atti di amore e di amicizia. Si parlava meno di sharing economy in quegli anni, ma nel caso di Couchsaurfing di sicuro c’era molto più sharing che economy. «Eh già», dice John prima di finire la sua tazzona di caffé, infilarsi le scarpe e andare in laboratorio, «era proprio tutto vero».
Personalmente posso testimoniare la stessa cosa sulla base di almeno una ventina di viaggi, in Europa, in Nord Africa e in Medio Oriente, effettuati utilizzando CS tra il 2008 e il 2012, durante i quali ho conosciuto decine di persone e stretto almeno una mezza dozzina di amicizie vere, alcune durate negli anni, ma che all’inizio erano sempre incontri con sconosciuti contattati via internet e recensiti dalla rete stessa degli utenti grazie ai loro feedback.
Anche John e Alice hanno accumulato parecchie esperienze con Couchsurfing e ricordano quegli anni con affetto. Quelle esperienze di condivisione sono state una grande ispirazione per iniziare a usare Airbnb. «Spesso abbiamo l’impressione di ospitare degli amici, ma devo dire che non è la stessa cosa», dice John mentre si infila le scarpe per andare a lavoro.
Non è la stessa cosa, già. Da una parte, le cose sono cambiate in meglio, e infatti Airbnb è esploso proprio mentre si eclissava Couchsurfing, intorno al 2011. L’affiancamento del pagamento al sistema dei feedback introdotto da Airbnb ha bonificato quello che in Couchsurfing stava iniziando a dare dei problemi, ovvero il rapporto tra chi ospitava e chi veniva ospitato, che in un regime di gratuità è poco protetto. Dall’altra, l’avvenuta scissione tra l’offerta di un alloggio e la presenza di colui che ospita ha minimizzato le possibilità di creazione di una commuity dal basso, di persone che si conoscono realmente e realmente stringono amicizia.
Su Couchsurfing il tessuto dei rapporti, almeno fino al 2011, era molto forte. Chiunque l’abbia usato ai tempi d’oro probabilmente avrà ancora amici il tasso di reincontro non solo era molto alto, ma era uno degli obiettivi della piattaforma, che favoriva il “non perdiamoci di vista” grazie all’uso delle amicizie in stile Facebook.
Bingo. Funzionava. Il rapporto tra ospitante e ospitato, tra host e guest, per dirla con il lessico di Airbnb, si creava sul serio e spesso continuava anche oltre il tempo del soggiorno. Poi che successe? Da una parte, l’esplosione di Airbnb ha eroso la base degli utenti di Couchsurfing, soprattutto quella parte della community meno “engaged”, come piace dire all’ufficio marketing, ovvero quelli che erano interessati più a dormire gratis piuttosto che a condividere esperienze e conoscere gente. Dall’altra, una specie di suicidio (il trasformarsi di CS da società no-profit a profit, proprio nel 2011), oltre a un caso di stupro che fu molto mediatizzato, nel 2012. Qualcosa si era rotto. Fu in quei mesi che la community cominciò a frantumare dall’interno.
Resta il fatto che, per circa un lustro, la comunità che si formò intorno a Couchsurfing fu un esempio forse più unico che raro di cosa può fare internet per far incontrare le persone senza per forza doverci fare dei soldi. Sembrava la ricetta perfetta, il win-win, la quadratura di un cerchio bellissimo. La community era una gigantesca rete di comunità, di gruppi di amici che si creavano sulla base di una condivisione di spazio e di tempo totalmente gratuita. Qualcosa che ha il sapore di un mondo che, pur lontano due passi nel passato, sembra archiviato. Il mondo prima di Airbnb.
Quello che raccontano John e Alice è un ricordo che in tanti condividono con un filo di nostalgia. Un po’ come i vecchi tempi dei blog e, come quello, sembra ormai appartenere a un’epoca perduta di internet: una rete più semplice, meno centralizzata e dominata dai giganti della Silicon Valley, una rete dove con una buona idea si poteva creare qualcosa di bello, pulito e giusto, per usare le categorie che usiamo anche noi su Slow News.
Per capire il successo di Airbnb, bisogna accettare che, in qualche modo, è proprio da quel mondo che è nato. Basta andarsi a leggere la leggenda privata dei fondatori che nell’autunno del 2007, disperati e senza un soldo, comprarono una serie di materassini gofiabili — gli Air-bed —, li affittarono online a gente che ne aveva bisogno per qualche notte. Non fu un successo da subito, raccontano da più di un decennio, ma tirarono su due soldi per pagarsi l’affitto, mettendo le basi per diventare da lì a pochi anni tra gli uomini più ricchi del pianeta.
Airbnb, come un Anakin Skywalker qualsiasi, impara quel che c’è da imparare dai maestri — in questo caso Couchsurfing — ma ci infila qualcosa che con la comunità vera e con il vero senso della condivisione c’entra poco o nulla: ci mette dentro i soldi, ne fa un gioco al profitto, cerca di dopare la community con gli steroidi di un gaming improntato all’individualismo. Il risultato? Dice di voler creare una comunità, disgregando la comunità. Perché, fateci caso, su Airbnb non ci si reincontra. Mai. Per definizione. E non c’è da stupirsi, malgrado i bei discorsi, siamo ancora in pieno nel campo del turismo di massa, quello che fa andare di moda le cartine in cui cancellare i paesi già visitati come si attacca una figurina a un album e si dice Celo. È la grande religione dell’One Night Stand del viaggiare. Rifugge i legami. Non prevede ricorsività.
In un campo da gioco come quello di CS, in cui nessuno era servo e nessuno era padrone, ma tutti alla pari, Brian Chesky e Joe Gebbia, quando gonfiano i loro materassini che puzzava di PVC, probabilmente senza nemmeno rendersi conto, prendono la celebre dialettica hegeliana tra il servo e il padrone e la infilano ben dentro il nostro orgoglio, nel pro difondo ognuno di noi. Non sono i soli. È il gesto tipico di quella che ama autodefinirsi “sharing economy”: metti la pulce del poter essere padrone all’orecchio di ogni servo e vinci la lotta di classe in una mano sola, con un all-in da campioni del mondo.
Servi e padroni, contemporaneamente. Una duplicità schizofrenica che però, come abbiamo visto quando abbiamo spiato le mosse della giovane coppia di parigini in vacanza a Edimburgo (cfr. Episodio 1), riguarda tutti noi molto più profondamente di quanto spesso non immaginiamo. Ci ritorneremo.
«La gente sa che cos’è un superbrand, ha ben presente le Apple, le Nike, le Coca Cola, le Disney. Intuisce anche cosa siano i brand “community-driven”, come le squadre di calcio, cose del genere, ma questi ultimi non sono iconici come i superbrands. Quello che stiamo cercando di fare noi è di mettere insieme queste due cose in un modo che non è mai stato fatto prima d’ora».
A dire queste parole — più o meno, la traduzione è un po’ libera ed è mia, qui trovi tutta l’intervista originale — è Jonathan Mildenhall durante un’intervista rilasciata a metà del 2015, dopo circa un anno e mezzo che occupava la posizione di CMO — Chief Marketing Officier — all’interno di Airbnb. Da quell’intervista sono passati quasi cinque anni e, anche se Mildenhall ha lasciato il suo incarico nel 2017, quella aspirazione è diventata parte integrante del DNA di Airbnb, che nel frattempo è cresciuta a una velocità impressionante.
Secondo i dati più aggiornati che ho trovato, al dicembre del 2019, Airbnb avrebbe oltre 150 milioni di utenti registrati in tutto il mondo, di cui 650mila sono host che mettono in affitto circa 7 milioni di case — 2 milioni di queste sono prenotabili all’istante, come in hotel — in circa 80mila città sparse in 191 paesi del mondo. E ancora, Airbnb tratta 500mila prenotazioni al giorno, in tutto 2 milioni di ospiti e vale ad oggi 38 miliardi di dollari. Dal punto di vista strettamente economico finanziario, nel 2017 prevedeva un EBITDA (utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti) di 450 milioni di dollari e un totale di 2,8 miliardi di dollari di fatturato ed è ormai prossima alla quotazione in borsa che, si aspettano gli analisti, sarà abbastanza fragorosa e dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno.
Insomma, Missione Superbrand compiuta sia a livello economico che di brand awarness. Tutti conoscono Airbnb. Praticamente tutti lo hanno usato almeno una volta, esattamente come tutti o quasi hanno bevuto una Coca Cola nella propria vita o hanno visto un cartone animato della Disney.
Ma difficile dire lo stesso della missione Community-driven. E infatti, nonostante al momento Couchsurfing a confronto con il gigante Airbnb sia ormai poco più di un nano zoppo in fin di vita, viene da pensare che i fegati dei vertici del colosso del turismo a breve termine californiano si corrodano dall’invidia ogni volta che pensano a quel piccolo miracolo che, per quasi un lustro, ha fatto diventare Couchsurfing un fenomeno sociale: la sua community densa e affiatata, esattamente quello che manca a Airbnb, anche se praticamente ogni mossa che fa e ogni soldo che spende in comunicazione e marketing vorrebbe dimostrare il contrario.
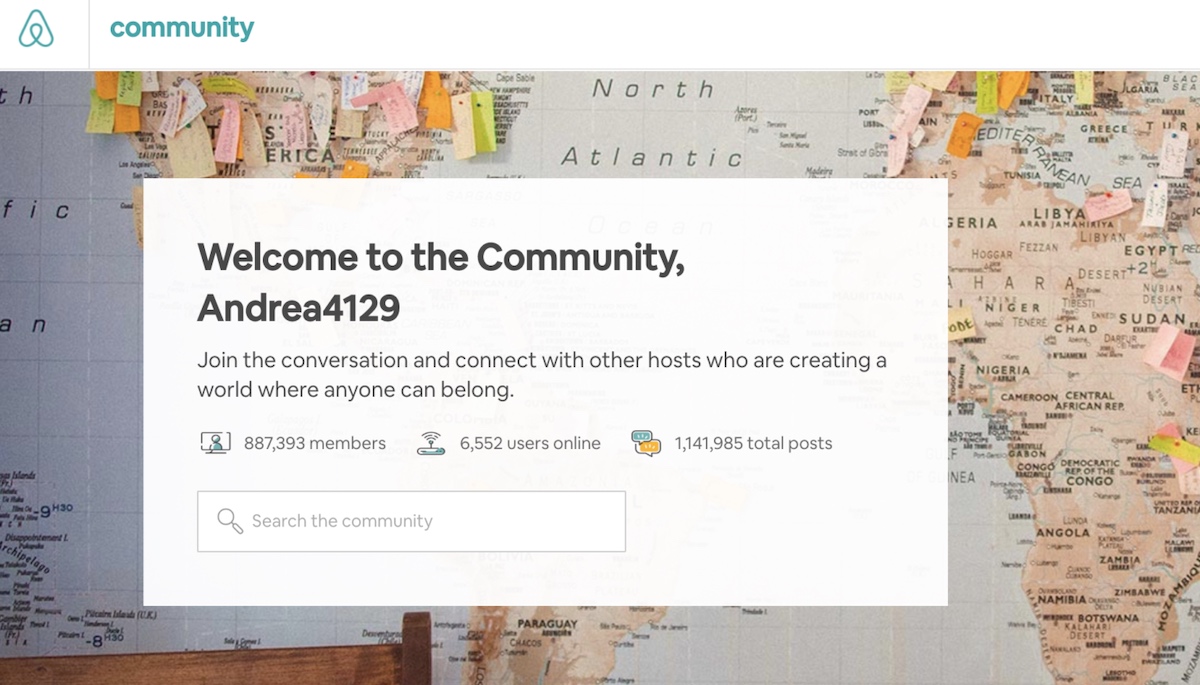
Se il corpo di Airbnb somiglia già a quello di superbrand come Coca Cola o Disney, la testa di certo non somiglia ancora a quella di un Barcellona, di una Juventus o di un Real Madrid. I suoi tifosi ce li ha, certo, ma non ci potrebbe ancora riempire uno stadio. Quello che serve a Airbnb è una community di persone in carne ed ossa che si incontrano e organizzano eventi nella realtà, diventando così una forza — gratuita — per rivendicare, diffondere e proteggere gli ideali e gli interessi di Airbnb stessa. E questo, Airbnb lo sta provando a fare, investendo svariati milioni di euro e provando, come abbiamo visto, piste parallele.
Dal punto di vista della creazione e del mantenimento della community, Airbnb investe un sacco di soldi da anni, lanciandosi in diversi progetti negli ultimi 3 anni. Ma quanto è grande la community di Airbnb? Sulla carta, anzi, sulla pagina web appositamente creata e fatta di forum e discussioni tra host su qualsiasi tema, è tanto, tanto grande. È la fascia alta della community e, nel momento in cui scrivo questo articolo, i membri iscritti sono 885.359. Un numero impressionante in assoluto, anche se si fa un po’ pallido e timido se messo di fianco al numero totale degli utenti registrati, che al momento sono più di 150 milioni.
Meno dell’1 per cento. A questi, se vogliamo, possiamo anche aggiungere tutti coloro che, con i propri contenuti — le proprie foto su Instagram in primis — forniscono senza troppo pensarci una valanga di cosiddetti user generated content alla piattaforma, che risucchia e riusa gratis tutte le foto che le servono. Le basta contattare chi pubblica delle belle foto delle proprie esperienza usando gli appositi hashtag: la maggior parte delle persone non vede l’ora di vedere la propria foto fare il giro del mondo. A chi importa se il valore di quella foto — che per Airbnb è altissimo — viene totalmente ignorato?
Ma torniamo al sito ufficiale della community di Airbnb, che puoi raggiungere qui. Se sei un utente della piattaforma (basta averla usata almeno una volta nella vita) puoi loggarti con la stessa user e la stessa password. Io ci sono entrato loggandomi attraverso Facebook e ho fatto un giro tra i post e le discussioni — al momento ci sono esattamente 1 milione 141mila 985 post — e ho cercato di contattare due Community Manager per capire come funzionasse. Per ora non ho ricevuto alcuna risposta.
Tra le discussioni si trova di tutto. Problemi tecnici, dubbi legali, richieste di consigli per come migliorare il proprio annuncio e via dicendo. Tra le sezioni in cui è divisa, la parte più interessante, e probabilmente la più in linea con lo spirito di una community che ha l’obiettivo di far crescere l’azienda e il servizio, è quella che si intitola Host’s Voice, dedicata alle idee e alle proposte degli Host.
La sensazione, però, è un po’ quella di entrare in una casa disabitata da un po’. È tutto in ordine, ma un centimetro di polvere ricopre ogni cosa e blocca il tempo. Il banner in testa alla pagina annuncia che presto ci saranno grandi novità, ma l’ultimo messaggio è datato 26 aprile 2018. Il motivo lo si scopre in fretta. In un piccolo banner laterale color verde acqua si legge: «Hold that thought! As we improve how we gather and share your questions, we’re temporarily pausing submissions. Thanks for your patience!»
Il contatore dei post segnala che ci sono 628 “nuove“ idee, di cui 23 ”popolari”. 7 post sono “Under Consideration” e 1531 sono quelle archiviate. Quando vado a sbirciare in quelle archiviate finisco per caso in un messaggio che mi colpisce. Lo ha scritto una utente di Boston, Lori11, il 16 giugno del 2017.
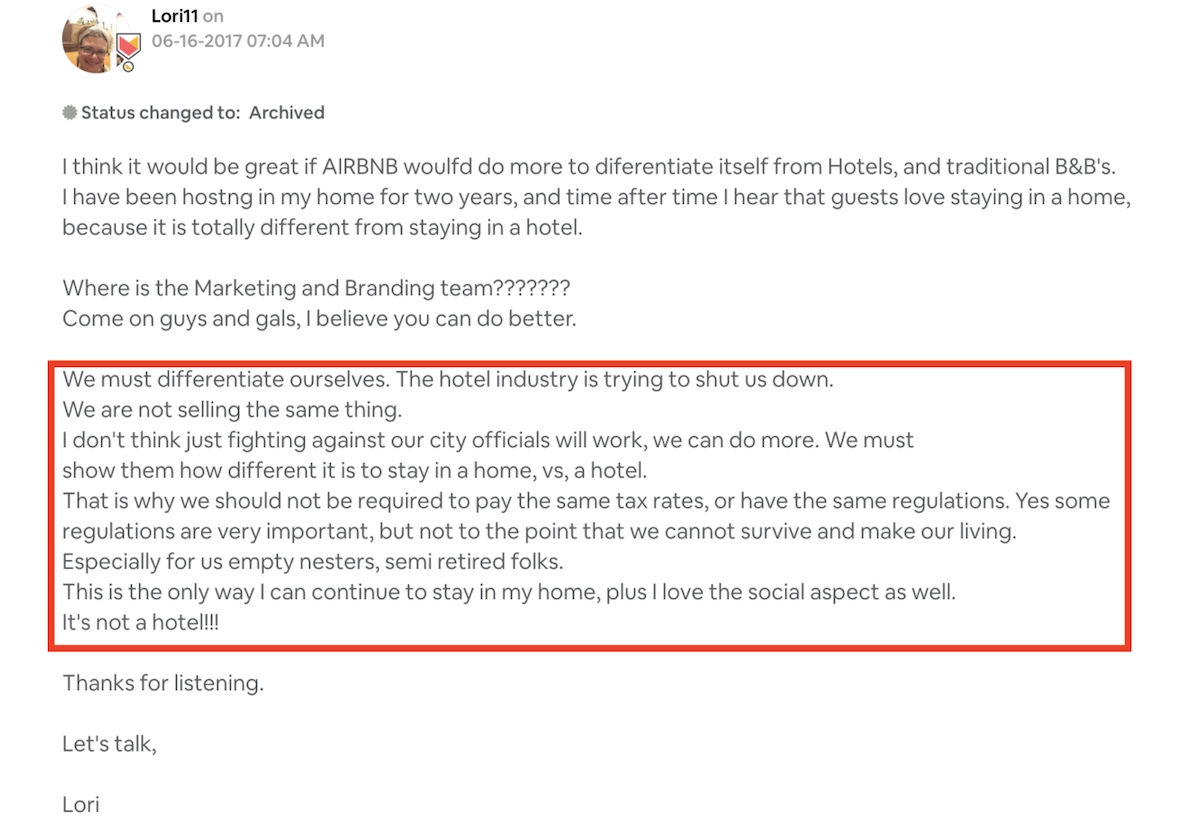
È stato il titolo del post a richiamare la mia attenzione: Airbnb Marketing Strategy. Il messaggio, come puoi leggere, problematizza quella che a Lori sembra una lacuna strategica di Airbnb, ma la parte più interessante è quella più personale, che lascia trasparire una storia molto simile a quella di Christine (cfr. Episodio 3). Lori, come Christine, è quella che in inglese si definisce una “empty nesters, semi retired folk”, ovvero una madre i cui figli sono usciti di casa e che è prossima alla pensione. Come Christine, anche per Lori l’introito che le arriva da Airbnb è molto prezioso: «This is the only way I can continue to stay in my home». La passione per la parte sociale dell’esperienza è messa al secondo posto.
Quello di Lori, senza capslock ma con tanti punti esclamativi, è un grido di allarme: senza Airbnb non sarebbe in grado di pagare l’affitto. Lori abita in una villetta di tre piani con giardino di cui affitta contemporaneamente più spazi: l’intero attico, al terzo piano, dove ci stanno fino a 4 persone, e una stanza al secondo piano, per altre due. Lei vive al secondo piano, poco lontano dalla stanza singola. La villetta di Lori è a pochi minuti dalla metropolitana, poco a sud del centro, e a quanto dice, se non affittasse su Airbnb dovrebbe lasciare quella casa. Non sono riuscito a mettermi in contatto diretto con Lori, ma quello che scrive è molto credibile.
Ma al di là della storia personale di Lori e di quella collettiva della città di Boston, una delle città in prima linea contro l’uso speculativo di Airbnb, cosa ci dice questo post sulla community di Airbnb. È un messaggio interessante, che cerca di coinvolgere gli altri utenti e la stessa Airbnb e contiene uno sfogo personale che sulla carta dovrebbe riguardare e coinvolgere tante persone.
Nella pagina di benvenuto per i nuovi arrivati si legge che “Airbnb vuole creare un mondo in cui chiunque possa sentirsi a casa propria, ovunque, e al centro di tutto c’è la sua community. Il Community Center è progettato per permettere agli host di riunirsi per dare e trovare ispirazione, condividere conoscenze e storie, nonché sostenersi a vicenda”.
Sostenersi a vicenda. Un po’ quello di cui probabilmente aveva bisogno Lori in quel mese di aprile del 2017. Eppure, quel post ha ricevuto solo una risposta e quattro like. La risposta, brevissima, risale al giorno successivo all’invio del messaggio da parte di Lori, l’ha scritta l’utente esperto (livello 10, praticamente un supersayan) Bruce43 da Kfar Blum, in Israele, e fa così: «@Lori11 you are absolutely right. The sharing economy is a joke, just who are we sharing it with?». Poi, il nulla.
Un po’ povero come abbraccio di comunità. Non credi?
A metà novembre del 2019, in tutta Italia, Airbnb ha organizzato un evento diffuso intitolato 100 case 100 idee. Sul sito dedicato all’evento leggiamo un riassunto dei principali dati: «1200 partecipanti ai tavoli di discussione, 100 luoghi collegati via chat e video, oltre 1000 televoti in diretta, 280 host organizzatori e 2500 tweet hanno fatto diventare l’evento, vere e proprie primarie dell’ospitalità, uno dei “trending topic” della giornata».
Sarah Gainsforth, che ha scritto nel 2019 uno splendido libro sugli effetti del fenomeno Airbnb sulle comunità intitolato Airbnb, città merce. Storie di resistenza alla gentrificazione digitale, quel giorno era a Firenze, all’Istituto Europeo di Design, sede dell’incontro organizzato da Airbnb nella città toscana. Quello che descrive, che puoi leggere qui, sembra tutto fuorché un incontro sano di una comunità esistente e viva.
«Alcuni membri dell’organizzazione, cartellini sul petto, sostano in piedi in vari punti della sala», scrive Sarah, «si muovono tra le sedie, si fanno cenni, sorvegliano. La regia è ferrea: tutto si svolge come da copione, ci sono state le prove generali». È tutto vero: c’è un canovaccio che Airbnb ha inviato, il 13 novembre, meno di due giorni prima dell’evento, agli host che si erano registrati.
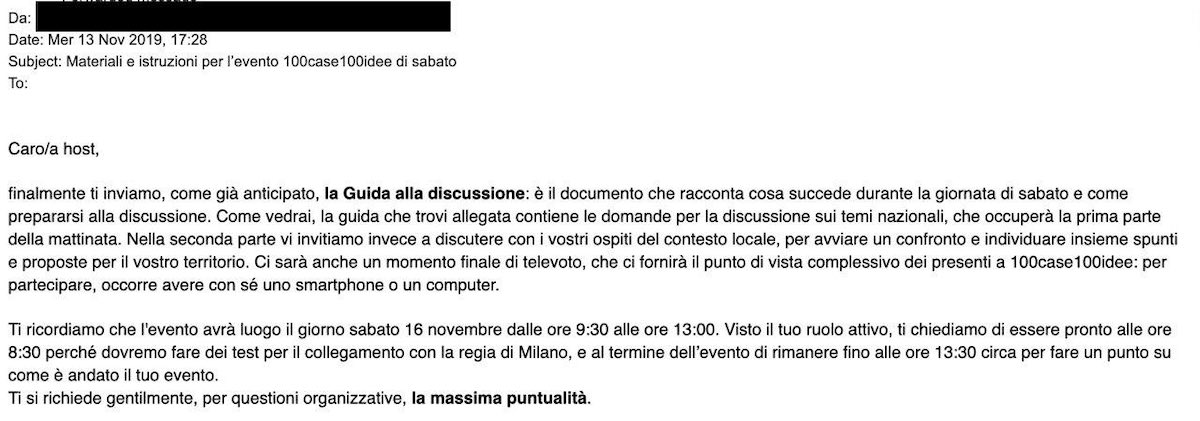
Anche le prove generali di cui parla Sarah si sono svolte veramente:
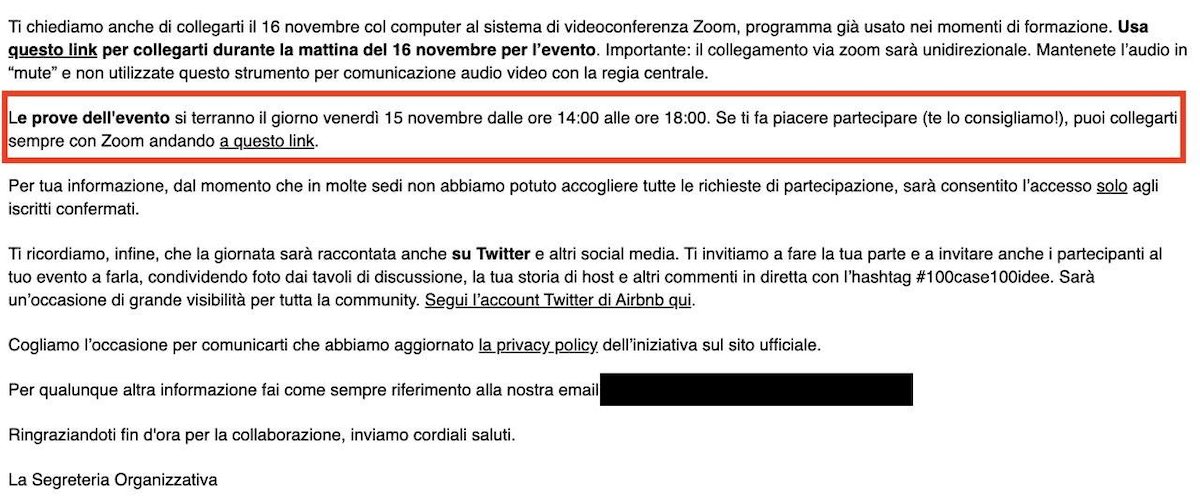
In allegato alla mail, un documento in pdf che spiega, in 24 paginette con anche i disegnini, gli obiettivi e i temi in discussione durante queste fantomatiche “primarie dell’ospitalità”. In particolare, sono due le domande che Airbnb — o forse semplicemente l’agenzia di marketing che ha organizzato il tutto, Labins, Laboratorio di innnovazione sociale di Torino.
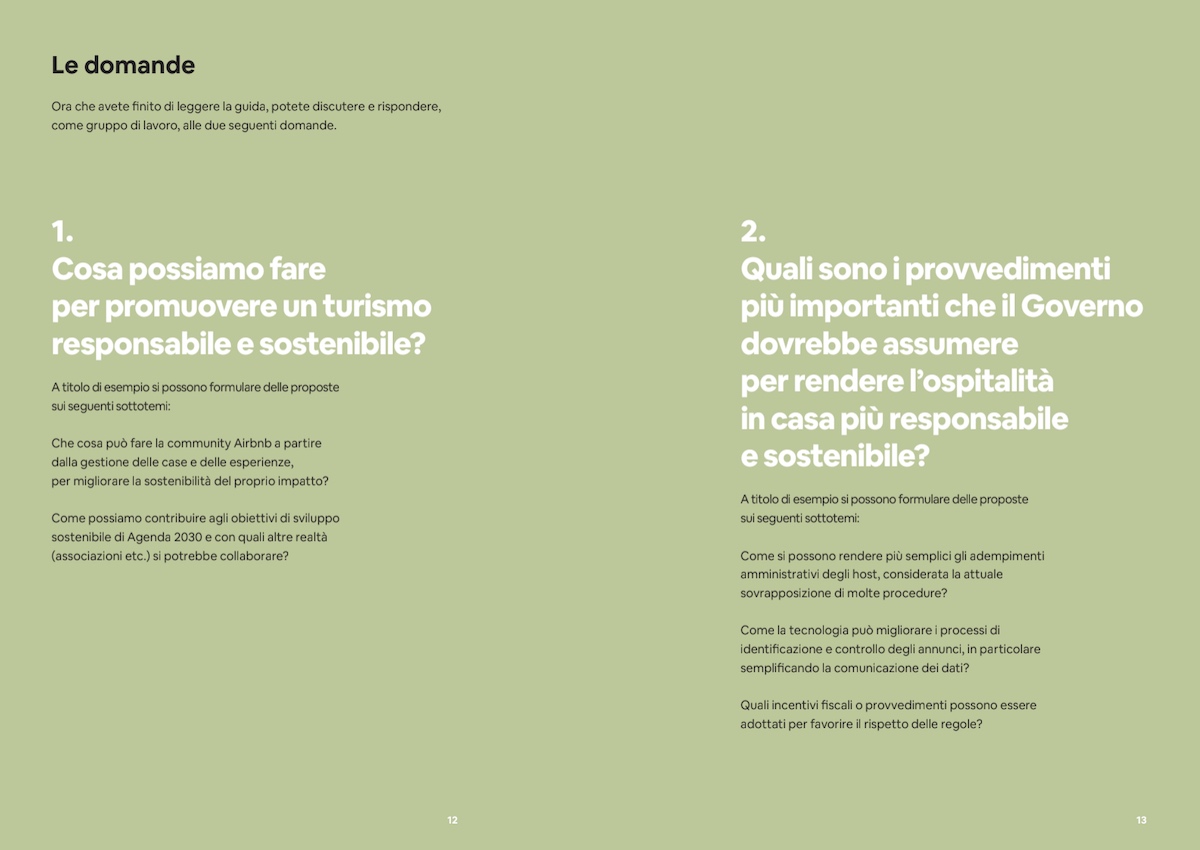
Per problematizzare quello che è emerso durante quelle ore ti lascio alla cronaca completa di Sarah, qui ora non ci interessa fare emergere la strategia di Airbnb e la sua eventuale malafede nell’organizzare un dibattito su se stessa togliendo di mezzo l’elefante che si sta putrefacendo nel corridoio. Quello che ci interessa è semplicemente cercare di capire quanto questa serie di eventi sia soprattutto una operazione di marketing e storytelling, piuttosto che quello che dice di voler essere, ovvero un incontro, come recita il documento di cui sopra, “aperto a tutti ed è auto-organizzato dalle
community di host Airbnb”.
Per capirci di più ho cercato una fonte indipendente. Qualcuno che avesse partecipato a uno degli incontri del 15 novembre “da dentro“ e così, come ci stiamo abituando a fare a Slow News quando ci mettiamo a lavorare a qualche serie, ho chiesto aiuto alla nostra di comunità quella dei nostri lettori e delle nostre lettrici. Tra la dozzina di persone che mi hanno contattato in privato, mi ha scritto anche Eleonora, poco più di 40 anni, per metà freelance della comunicazione e per l’altra affittuaria di camere in locazione turistica a Oristano.
Eleonora usa Airbnb come host da un anno. Come guest invece, è abituata a usarlo da più tempo. MI spiega che ha messo gli annunci delle mie locazioni su Airbnb perché è un’ottima soluzione per avere più richieste d’affitto, ma anche che non è l’unica piattaforma che sfrutta. «Ho anche altri canali privi di intermediazione», dice, «il sito, i miei canali social e così via, e visto che affittare stanze è il mio è un secondo lavoro, grazie a questi strumenti riesco a riempire le camere con pochi sforzi».
Eleonora fino al 15 novembre non aveva mai seguito sul serio la community su Airbnb. Le è sempre sembrata una perdita di tempo. E di tempo, come tutti noi, ne ha già sempre troppo poco. “100 case 100 idee” è il primo evento della community a cui partecipa e il suo punto di vista ci interessa: «Per me, personalmente, alla fine è andato bene, ma ho notato una organizzazione veramente scarsissima: la segreteria organizzativa ha chiaramente prediletto alcune location, le più grosse e visibili, lasciando le piccole e disperse come la mia nella disperazione totale. Inviti non risposti, gente che non aveva avuto l’indirizzo o la conferma dell’evento e altri problemi. L’idea è stata ottima: la gente da me ha partecipato ed ho scoperto che ci sono molte dinamiche da correggere, troppe direi, e nel mio territorio intendo aiutare anche io».
Ad oggi ci sono circa 400 mila alloggi in affitto su Airbnb in Italia e in tutto gli host sono all’incirca 100mila. L’evento a cui Eleonora ha partecipato e che le sembrava un’ottima idea, secondo le stesse dichiarazioni di Airbnb ha avuto più risonanza mediatica che impatto: poco più di 1000 le persone coinvolte e, come dice Eleonora, la sensazione diffusa che l’organizzazione centrale abbia “prediletto alcune location, le più grosse e visibili“ lasciando i piccoli al loro destino.
Airbnb ripete ovunque che la community è la cosa più importante. Ma a cosa gli serve? Sembra una domanda scontata, ma è molto più sensata di quel che sembra. Perché Airbnb spende tutti questi soldi per creare qualcosa che a cui non corrisponde, quantomeno non direttamente, un aumento sostanziale del fatturato (che d’altronde sembra già bello che consolidato di suo)? Spende veramente tutti quei soldi solo per “ripulirsi la faccia”? Può darsi. Ma allora la risposta che dovremmo darci è quella che si dà per esempio John Patrick Leary su Jacobin, in un articolo che commenta l’’Airbnb Magazine, che esagera sia con il sarcasmo che con la sufficienza scrivendo: «not only are they as stupid as ever, they seem to be getting desperate». Magari, John. Magari.
Sarah Gainsforth, invece, ha un’altra ipotesi. Il “partito di Airbnb”, così lo definisce in un articolo su Dinamopress di ottobre 2019, sarebbe l’arma segreta del colosso per fare pressione sulle comunità e sulle amministrazioni. Una sorta di lobbying dal basso da usare insieme a un’altra, più classica, dall’alto, a Bruxelles, dove cercherò di andare per uno dei prossimi episodi. Niente da dire, è molto, molto credibile.
Ma se ci fosse anche un altro obiettivo, molto più in linea con la più efficace arma di distruzione del conflitto di classe, ovvero il caro vecchio “Dividi et impera”? Se creare una Community online servisse ad alienare e disarticolare i soggetti che la compongono dalla comunità a cui realmente appartengono e a cui dovrebbero tenere, quella dei propri vicini di casa e di quartiere? Se persuadi un soggetto del fatto che appartiene più a una setta immateriale diffusa per il mondo che si parla via internet piuttosto che a una comunità fisica e materiale come quella dei vicini di casa o di quartiere, probabilmente sarà più facile che questo qualcuno si dimentichi della sua vera comunità. E anche che la tradisca.
Venezia è unica. Ma non è l’unica. E non è sola.
Soluzioni per contrastare lo spopolamento
Ticket d’accesso e Smart Control Room sono soluzioni contro l’iperturismo?
Il problema è l’iperturismo? O lo spopolamento? Oppure sono i soldi?