Il cielo color del vino
L’Aurora, secondo il gergo burocratico, è ua «azienda agrobiologica» ma tutti la chiamano «la cantina degli anarchici».
La storia del ferroviere anarchico che cadde dalla Questura di Milano pare che la conoscano tutti, ma non è così
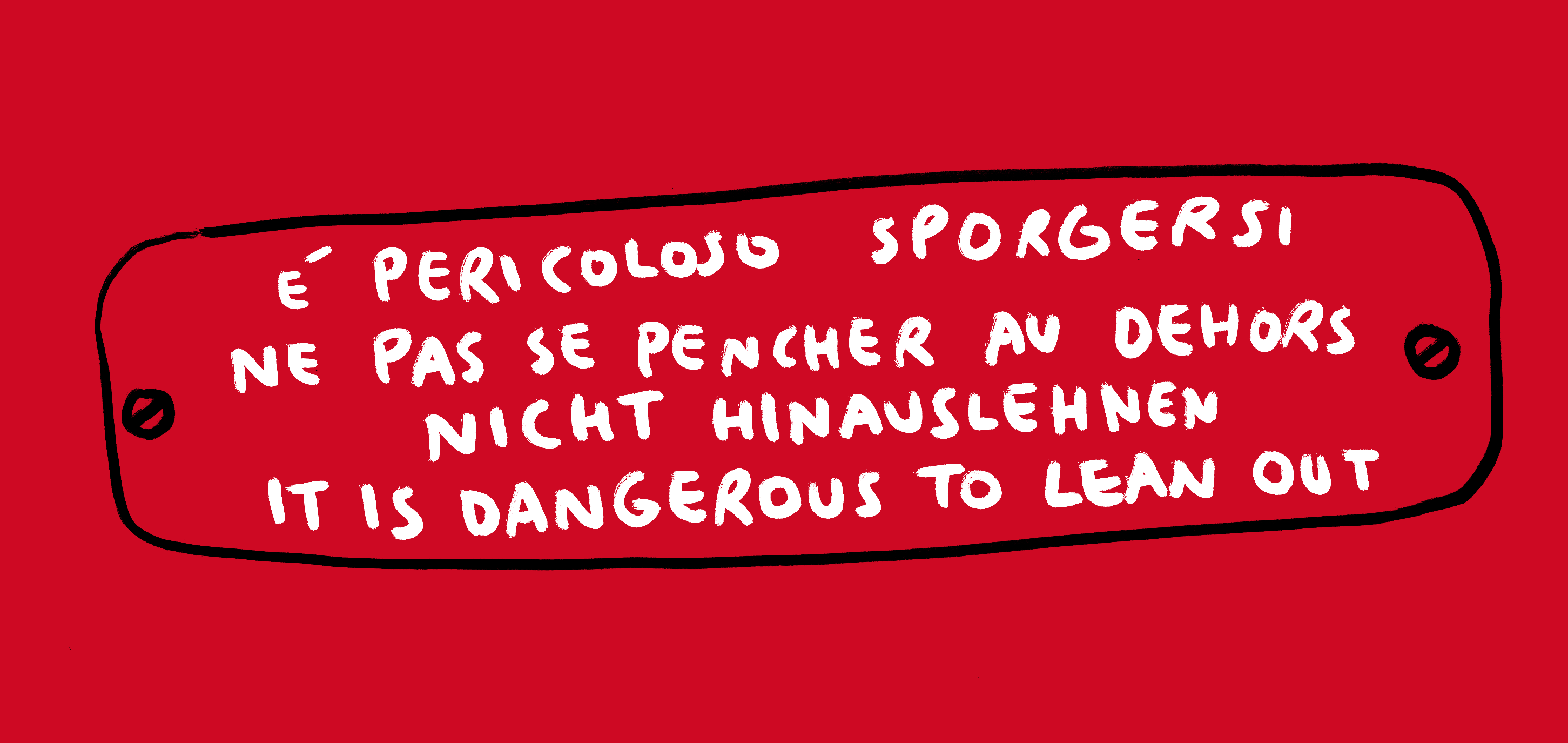
Una serie su un’ideale il cui nome si usa spesso a sproposito, e sulle persone che ne hanno fatto la storia

Il problema della storia di Giuseppe Pinelli è che la conosciamo tutti. Il ferroviere anarchico, la finestra aperta al quarto piano della questura di Milano, il commissario Calabresi. E la bomba di piazza Fontana, le inchieste, le controinchieste, le sentenze storte. Sappiamo tutto, nel dettaglio.
Abbiamo letto libri, ascoltato interviste, incontrato gente che a quel tempo già c’era e che ricorda, ricorda, ricorda. Mettere in fila i fatti è un lavoraccio tremendo quando di fatti ce ne sono così tanti e sono così tanto contraddittori. E poi il tempo, maledetto. Più passa e più i dettagli sfumano via, si mischiano tra di loro, ognuno li vede come li vuole vedere. Vale per tutte le storie, figuriamoci per quelle irrisolte. Già, perché malgrado sappiamo praticamente tutto di Pinelli, la sua è una storia senza finale.
Certo, si dirà, ci sarebbe una sentenza, ma quella forse è meglio lasciarla perdere. Ci sono delle scene. E da una di quelle vale la pena cominciare.

La notte tra lunedì 15 e martedì 16 dicembre 1969, la stanza del giovane commissario dell’Ufficio politico della questura di Milano Luigi Calabresi è piena di fumo. L’interrogato ha 41 anni, di lavoro fa il ferroviere e risponde al nome di Giuseppe Pinelli. In questura, Pinelli ci è entrato tre giorni prima, la sera del 12 dicembre, a poche ore di distanza dalla bomba scoppiata alla Banca dell’Agricoltura di piazza Fontana. Un attentato per il quale la polizia si è subito convinta che i responsabili siano gli anarchici. Ottantaquattro è il numero delle persone fermate nelle ore immediatamente successive all’esplosione.
Pinelli, la sera del 15, è detenuto ormai illegalmente, visto che le 48 di fermo sono abbondantemente scadute. Eppure è lì, nella stanza di Calabresi, al quarto piano della questura di Milano. E risponde alle domande insistenti degli agenti. Sempre le stesse. Gira e rigira quelle persone sono convinte che lui, Pino per gli amici, sappia ben più di quanto abbia detto di sapere sulla strage di piazza Fontana.
Sono ore che la storia va avanti sempre uguale a se stessa. Sono tutti stanchi, e fumano come matti. Una sigaretta via l’altra, spesso più di una insieme. I posacenere traboccano, l’aria è densa, pesantissima. Ci sono Pinelli, Calabresi, quattro sottufficiali di polizia e un tenente dei carabinieri.
Natale si avvicina, fuori fa un freddo che solo i milanesi conoscono davvero e le finestre della stanza sono socchiuse per far uscire via un po’ di fumo. È mezzanotte, più o meno, nel cortile della questura si aggira un cronista dell’Unità, Aldo Palumbo. È fermo sulle scale, si sta accendendo anche lui una sigaretta. Sente un rumore, con la coda dell’occhio vede qualcosa che cade dall’alto. Nel cortile c’è anche una guardia, tale Manchia. Lui non ha sentito niente di particolare, ma anche lui ha visto cadere qualcosa dal quarto piano. Un corpo, forse, ma lì per lì non capisce. Qualcosa brilla nel buio: la brace di una sigaretta. A mezzanotte e un minuto dalla questura parte una telefonata alla Croce Rossa.
I funerali dell’anarchico Pinelli avvengono il 20 dicembre, a Musocco, il cimitero maggiore di Milano. Ci sono i familiari, i compagni, gli amici. E c’è Franco Fortini, che di quel giorno scriverà una cronaca memorabile: «Quando siamo arrivati i becchini stavano calando la bara di Pinelli. Accanto alla sua ho visto calare, poco prima, un’altra cassa. Abbiamo alzato i pugni a salutarlo. Un frate ha cominciato a dire in latino una preghiera. Pregava per quell’altro e i parenti dello sconosciuto si allontanavano da quella gente strana, venuta a sovrapporsi alla loro pena. Qualcuno, con tono brusco e professionale, mise in mano a una vecchia un foglio, scadendo il numero di riferimento della bara e del campo».
Pinelli, comunque, adesso riposa al cimitero di Turigliano, a Carrara, e sulla sua lapide ci sono alcuni versi della poesia Carl Hamblin di Edgar Lee Masters, nella traduzione italiana di Fernanda Pivano. Il brano è contenuto nell’Antologia di Spoon River, libro che Pinelli aveva regalato al commissario Calabresi nella primavera del 1969, una cortesia in un momento di tensione: erano in corso le indagini per alcune bombe esplose nel mese di aprile.

Scene. Momenti. Pezzi di una storia molto più grande ma, davvero, in fondo quello che riguarda Pinelli è tutto qui. Il resto è altrove, sfuggente, quasi inafferrabile nella catena di eventi che dal 12 dicembre del 1969 arrivano fino ai giorni nostri. Molti hanno dimenticato, altri hanno fatto finta di farlo, e adesso la storia di Pinelli riaffiora nelle cronache mediamente una volta all’anno, quando ricorre l’anniversario della bomba di piazza Fontana. L’ultima volta, la ricorrenza era di quelle importanti: cinquant’anni. Mezzo secolo di ombre che si muovono nel buio. E poche finestre aperte per far entrare la luce. Il fronte anarchico arriva spaccato all’appuntamento con il cinquantesimo. Da una parte i compagni del Circolo Ponte della Ghisolfa, la casa politica di Pino Pinelli, dall’altra le figlie Silvia e Claudia. E poi c’è Licia, la figura più grande di tutte, la vedova Pinelli, 91 anni.
Che cosa è successo? Claudia, Silvia e Licia hanno organizzato per il 14 dicembre una catena musicale che da piazza Fontana dovrà arrivare fino alla questura. Aderiscono in molti, da tutta l’Italia. Singoli, sigle, gruppi, associazioni, anarchici, comunisti, cattolici, democratici, proletari, borghesi, aristocratici. Quelli del Ponte, però, non sono d’accordo.
Sostiene Mauro Decortes, storico militante del Circolo: «Nei testi diffusi dalla catena musicale manca sempre il contesto di quegli anni, inizialmente non era nemmeno citato Valpreda… Noi siamo sempre stati aperti, abbiamo invitato a partecipare tanta gente, non solo del mondo anarchico. Il problema non è però l’apertura verso l’esterno, ma il fatto che ci devono essere dei valori e dei caratteri chiari. Non ci piace che tutto debba ridursi a una sorta di messa obbligatoria, certe lotte sono ancora vive e questo va ribadito sempre. Pinelli, d’altra parte, non era solo un padre di famiglia, ma anche un compagno, un militante molto attento che immaginava e lottava per una società diversa. Non possiamo fare di lui una figurina istituzionale. Diceva Valpreda che credere nella verità non vuol dire credere nella giustizia».

Risponde Silvia Pinelli: «Abbiamo deciso di fare le cose in maniera più aperta e plurale possibile. D’altra parte anche cinquant’anni fa per Pino si mosse la società civile, i compagni certo, ma anche un fronte che andava dai cattolici all’alta borghesia. Penso a Camilla Cederna, tanto per fare un esempio. È quello che vogliamo far accadere anche adesso con la catena musicale».
Gli animi si scaldano, i toni si accendono, si parla molto, moltissimo, forse pure troppo. Volano parole grosse.
Ancora Silvia: «Siamo state attaccate senza motivo e sempre sul personale. Fa male perché in tanti anni non ci è successo con la polizia, i fascisti o la mafia, e invece adesso certe parole arrivano da parte di persone che pensavamo essere nostre amiche».
Conclude Mauro: «È una questione che ci addolora, sono state dette e scritte tante falsità anche su di noi, e comunque voglio sottolineare che con Licia non ci sono mai stati problemi, anzi ci sentiamo spesso ancora adesso. C’è molta psicologia in questa storia, molte questioni di ego, come se una parte della sinistra volesse comparire e basta, un po’ per piccoli interessi e un po’ forse per senso di colpa. La nostra, ad ogni modo, è una critica politica e non personale».
Il Ponte della Ghisolfa è un nome poco meno che leggendario nel mondo anarchico italiano. Fondato il primo maggio del 1968, tra i suoi animatori in quegli anni, oltre a Pinelli, c’era Pietro Valpreda. «È lui», disse di Valpreda il tassista Cornelio Rolandi, identificandolo come l’uomo che portò in piazza Fontana, il pomeriggio del 12 dicembre. Peccato che quel giorno Valpreda fosse malato. Un alibi debole, che infatti non viene creduto. La sua assoluzione arriverà solo nel 1987, dopo 1110 giorni di carcere. Durante il suo soggiorno da ospite dello Stato a Regina Coeli, ilmanifesto decide di candidarlo come capolista alla Camera alle elezioni politiche del 1972, con l’obiettivo di fargli ottenere la scarcerazione grazie all’immunità parlamentare. L’impresa va male: Valpreda prende 11.605 preferenze, la lista oltre 32.000 nella circoscrizione di Roma, senza tuttavia raggiungere il quorum. Per anni, Valpreda è stato considerato «il mostro di piazza Fontana», come da definizione coniata dall’Unità, il quotidiano del Partito Comunista. Bruno Vespa al telegiornale di Raiuno lo presenta come il «vero e sicuro colpevole» della strage, Mario Cervi tira fuori persino Lombroso, in un articolo uscito sul Corriere della Sera il 17 dicembre del 1969: «il criminale ha un volto, la sua salute è insidiata da un’infermità grave, il morbo di Burger. La menomazione che lo impedisce, lui ballerino, nelle gambe, potrebbe aver contribuito a scatenare una forsennata e irrazionale avversione per l’umanità intera».
Il fatto che Valpreda sia un ballerino colpisce molto l’opinione pubblica, ma non è uno di quei particolari che ispirano simpatie, anzi, al contrario, la sensazione è che la cosa serva solo a dare al personaggio un’ulteriore sfumatura di devianza, di marginalità, di inaccettabile promiscuità nell’Italia che ancora guarda con sospetto la rivoluzione sessuale. Il mostro è mostro in ogni suo aspetto: lui da una parte e le persone normali dall’altra. Uscito di galera, assolto e riabilitato nel silenzio colpevole e un po’ imbarazzato dei media, Valpreda non ha mai rinnegato la sua militanza anarchica, e nei primi anni del nuovo millennio pubblica anche tre (bei) romanzi gialli con Piero Colaprico, la serie del maresciallo Binda: Quattro gocce di acqua piovana, La nevicata dell’85 e La primavera dei maimorti.
La figura di Valpreda, a conti fatti, è impossibile da scindere da quella di Pinelli: uno morto in questura, l’altro massacrato sulle pagine dei giornali e in televisione. Gli anarchici, «scacciati senza colpa», vanno via ma non possono dimenticare.

Siamo nell’ottobre del 1975 quando il giudice Gerardo D’Ambrosio, istruttore a Milano soltanto da tre anni, emette una sentenza che diventerà famosa per i motivi sbagliati. È quella del «malore attivo», espressione che non compare nel dispositivo ma che le sintesi giornalistiche dell’epoca hanno consegnato lo stesso alla storia. L’indagine, ufficialmente, è mossa da un triplice obiettivo: togliere di dosso da Pinelli l’alone del sospetto per la bomba, cercare di fare luce sulla notte in cui è morto e dimostrare che il commissario Luigi Calabresi non era nella stanza al momento della caduta dell’interrogato.
D’Ambrosio, alla fine, arriva davvero a credere che Pinelli sia caduto dalla finestra della questura dopo essersi sentito male. Lo stress, la lunga attesa, le sigarette, la fame, il freddo. A un certo punto Pino sarebbe collassato ma, invece di accasciarsi e svenire per terra, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto dalla finestra. I coinvolti non sono accusati di nulla: né di abuso d’ufficio, perché Pinelli al momento della sua morte era in stato di fermo illegale; né di falso ideologico, visto che all’inizio tutti dichiararono che Pinelli si era suicidato. E tutti hanno giurato e spergiurato che Calabresi, nel momento fatale, fosse uscito per andare dal capo Allegra. C’è soltanto una persona che sostiene tutt’oggi il contrario, ovvero l’unico testimone civile della vicenda: l’anarchico Pasquale Valitutti.
Valitutti, detto Lello, è un signore di 72 anni e in molti lo conoscono perché è quello che alle manifestazioni sta sulla sedia a rotelle e non si sottrae alla prima linea nemmeno quando la situazione è oltre il limite della tensione. Quando morì Pinelli, Lello aveva vent’anni e se ne stava seduto fuori dalla stanza degli interrogatori ad aspettare il proprio turno.
Mercoledì 4 dicembre 2019 alla Sapienza di Roma c’è la presentazione del libro «Piazza Fontana – Il processo impossibile» di Benedetta Tobagi, da poco uscito per Einaudi. Verso la fine, dal pubblico si leva una voce: «Vorrei sapere come fate a dire che Calabresi era uscito dalla stanza». Tobagi si consulta con la coordinatrice dell’incontro, Ilaria Moroni. Poi un po’ stizzita comincia a replicare, interrompendo la voce che dal pubblico continua a parlare. A un certo punto, visibilmente spazientita, Tobagi domanda: «Lei chi è, scusi?». Risposta: «Sono Valitutti».
Silenzio.

È un momento che può ricordare un duello da film western: da una parte c’è una giornalista che a sostenere la sua tesi ha le fonti documentali, dall’altra un militante che rivendica la propria presenza al momento dei fatti.
Valitutti, davanti a un pubblico attonito, comincia a parlare. Dice che da dove stava lui, quella sera, «vedeva perfettamente la porta dell’ufficio del dottor Allegra [capo della sezione politica della questura, nda] e la porta dell’ufficio del dottor Calabresi». E ancora: «Quindici, venti minuti prima della mezzanotte il silenzio venne rotto da rumori nell’ufficio di Calabresi, come di trambusto, di una rissa, di mobili smossi ed esclamazioni soffocate». A mezzanotte, racconta Valitutti, «ho sentito un tonfo che non ho più dimenticato e che spesso mi rimbomba» e prima «nessuno era uscito dall’ufficio e tantomeno entrato in quello di Allegra». Dopo il tonfo, «due sbirri si sono precipitati da me e mi hanno messo con la faccia al muro» e poi è arrivato Calabresi a raccontargli la sua versione dei fatti: «Stavamo parlando tranquillamente, non capisco perché si è buttato». Il mattino successivo, Valitutti viene rilasciato dalla questura. Il giudice D’Ambrosio non lo chiamerà mai a testimoniare, benché fosse lui l’unico civile presente al momento della morte di Pinelli.
Tobagi è interdetta, a questo punto, prova a reagire. Dice che nessuno ha santificato Calabresi, che nessuno vuole negare le responsabilità della squadra da lui diretta e che dalle indagini che ha fatto le risulta che il commissario fosse fuori dalla sua stanza in quel momento, ma non era andato da Allegra, bensì da Russomanno e dagli uomini degli Affari Riservati, pure loro presenti in questura. E qui, però, Valitutti la inchioda definitivamente: «Calabresi ha detto che è uscito per andare da Allegra. E ha mentito».
Tobagi, malgrado l’evidente resa dialettica, per la verità, le sue indagini le ha fatte bene e ha scoperto qualcosa che non si sapeva: quella sera in questura a Milano c’erano dieci o quindici funzionari dell’Ufficio Affari Riservati guidati da Silvano Russomanno, ovvero il vice dell’allora potentissimo Umberto D’Amato. La tesi di Tobagi è che siano stati loro a prendere il controllo dell’inchiesta sulla bomba di piazza Fontana, scavalcando l’ufficio politico di Allegra e Calabresi. Lei le prove le ha trovate e puntualmente scritte, anche se bisogna dire che questa storia gira ormai da anni, cioè da quando, nel 2013, il fondatore della Croce Nera Enrico Mantini e l’avvocato Gabriele Fuga pubblicarono il libro «E ‘a finestra c’è la morti» (edizioni Zero in Condotta). Il particolare, ad ogni buon conto, è uscito fuori grazie alla consultazione di parte dei 150mila fascicoli non catalogati presenti nell’archivio-deposito di via Appia, a Roma. I «dieci o quindici» degli Affari Riservati, per la cronaca e per la storia, non sono mai stati sentiti da nessun magistrato.
Siamo nel mezzo di un grande classico della storia italiana della seconda metà del ventesimo secolo: la palude, quel territorio in cui si affonda e basta, senza riuscire ad andare avanti né indietro. Tutti i fattacci dei cosiddetti anni di piombo sono pieni di zone d’ombra più o meno frutto di complottismi, più o meno rivelate a ragion veduta o a lume spento senza soluzione di continuità. Gli storici, tuttavia, sono ormai concordi su una cosa almeno: erano anni in cui pezzi anche molto grandi dello Stato hanno giocato sporco spesso e volentieri. Quella dell’anarchico che vola giù dal quarto piano della questura di Milano, in fin dei conti, è solo una parte della storia enorme della strage di piazza Fontana – la madre di tutte le stragi italiane -, un calderone che, solo a livello giudiziario, ha prodotto oltre trent’anni di inchieste e processi. Tanto per dire, la data della parola fine arriva soltanto il 3 maggio 2005, quando la Corte di Cassazione conferma la sentenza d’Appello in cui vengono assolti tutti i neofascisti e impone ai familiari delle vittime di pagare le spese processuali.

Maggio 2009, Roma, salone dei Corazzieri al Quirinale.
Ai margini della cerimonia per il Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi, si incontrano Licia Rognini, vedova Pinelli, e Gemma Capra, vedova Calabresi. Sono anni in cui concetti come «memoria condivisa» e «unità nazionale» vanno molto di moda, e le cronache dell’evento si sottraggono a questa retorica. Fioccano virgolettati come «fingiamo che non siano passati tutti questi anni» e «è assurdo che questo incontro non sia avvenuto prima». Più recentemente, 12 dicembre 2019, a palazzo Marino a Milano le due vedove si sono incontrate di nuovo. Racconta Claudia Pinelli: «Ci siamo parlate in modo normale, non so se questo porterà a una convergenza. Non c’è nessun percorso di riconciliazione, perché le famiglie non c’entrano in quello che è successo, ci deve essere un percorso di verità e non so se questo ci porterà a condividere». Nell’occasione, tra le altre cose, si segnala il sindaco Giuseppe Sala che chiede «scusa e perdono a Pinelli, a nome della città, per quello che è stato», aggiungendo anche scuse per Pietro Valpreda.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi, finalmente ammette: «L’attività depistatoria di una parte delle strutture dello Stato è stata doppiamente colpevole». La colpa di aver disonorato le istituzioni, ovviamente, ma anche quella di aver coperto troppe cose sulla strage.
Licia, dal canto suo, chiarisce una volta per tutte la propria posizione: «Non mi aspettavo che il sindaco Sala chiedesse perdono alla nostra famiglia. Io non mi aspetto niente da nessuno. Su come è morto mio marito la verità noi la conosciamo, noi le cose le sappiamo, poi se qualcuno ha voglia di parlare, parlerà».
Il corpo di Pinelli è sospeso nella memoria, quello che è successo al quarto piano della questura di Milano nella notte tra il 15 e il 16 dicembre del 1969 resta implicito.
Nel giardino di piazza Fontana ci sono due lapidi a ricordare la morte di Pino. Una è quella del Comune di Milano, e si parla di un «innocente morto tragicamente». L’altra è firmata dagli studenti e i democratici milanesi: «A Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico, ucciso innocente nei locali della questura di Milano». Il morto è stato ucciso. L’ucciso comunque è morto. Il finale è una sfumatura, ma la storia la sua verità ormai l’ha detta.
Una serie su un’ideale il cui nome si usa spesso a sproposito, e sulle persone che ne hanno fatto la storia

L’Aurora, secondo il gergo burocratico, è ua «azienda agrobiologica» ma tutti la chiamano «la cantina degli anarchici».
A Carrara le tracce degli anarchici sono ovunque: targhe sui muri, sedi, scritte, persino un monumento dedicato a Gaetano Bresci
La storia del ferroviere anarchico che cadde dalla Questura di Milano pare che la conoscano tutti, ma non è così
L’Aurora, secondo il gergo burocratico, è ua «azienda agrobiologica» ma tutti la chiamano «la cantina degli anarchici».
Le armi preferite dagli anarchici sono fatte di carta e non fanno male a nessuno: i libri e le riviste
Storia dell’anarchico Errico Malatesta, un eroe della gente che non vuole eroi
Ogni volta che c’è tumulto o caos, i giornali parlano di stato di anarchia. Cosa ne pensano gli anarchici?
Soluzioni per contrastare lo spopolamento
Venezia è unica. Ma non è l’unica. E non è sola.
Ticket d’accesso e Smart Control Room sono soluzioni contro l’iperturismo?
Il problema è l’iperturismo? O lo spopolamento? Oppure sono i soldi?