Kiev-Milano, andata e ritorno
La storia di Aliona Fedchyshyna: «Così ho aiutato gli altri profughi ucraini in Italia, prima di tornare a casa».

Dal campo, il racconto del doppio standard di accoglienza dei profughi ucraini in Europa.
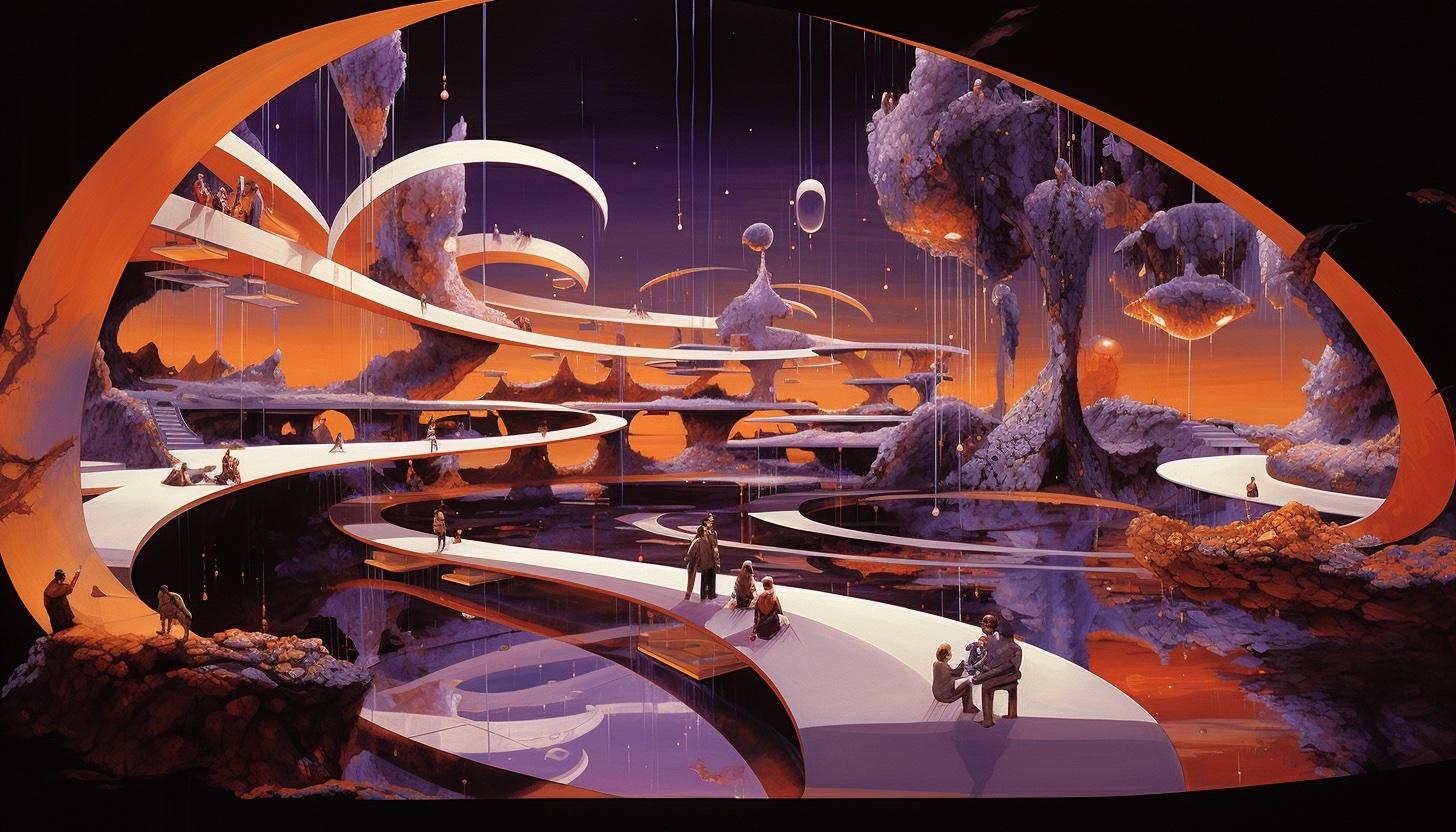
Quando a marzo Iana Kuko ha lasciato la sua città, Orichiv, nella regione di Zaporizhia, in Ucraina, iniziavano già a mancare sia cibo che acqua. Le altre città intorno erano state occupate: «era questione di giorni ed era troppo rischioso restare, avevo paura dei bombardamenti, ma temevo anche di rimanere in trappola e non riuscire più ad andare via», racconta. «Così ho messo insieme poche cose in una valigia e sono partita». Il lungo viaggio che la porta via da Orichiv inizia con un treno notturno verso il confine polacco, poi la tratta fino a Varsavia. Qui la primissima accoglienza è una brandina nera sistemata nel padiglione undici dell’ex Expo della città, riadattato a centro per i profughi in fuga.
Quasi settemila persone sistemate in grandi container, dove un tempo si esponevano merci e oggi si prova a ricostruire pezzi di vita. Un padiglione è adibito a dormitorio, accanto c’è la mensa e una stanza per i giochi dei bambini. Kuko sa che da qui può raggiungere facilmente la sua meta finale: l’Italia. Dentro il padiglione undici c’è un desk allestito dalle organizzazioni non governative Caritas italiana, Open Arms e Solidaire del tutto simile a quelli che si vedono negli aeroporti. Da marzo le tre organizzazioni hanno iniziato a fare i primi voli umanitari dalla Polonia all’Italia e la Spagna, portando via ogni volta circa duecento persone a tratta. «Lavoro per un’azienda che ha diverse sedi all’estero. Quando è scoppiata la guerra i colleghi italiani mi hanno subito invitata, mi hanno detto di andare via, mi avrebbe ospitato loro» spiega Kuko, atterrata a Roma il 21 marzo scorso. Per cinque settimane ha vissuto a Viterbo nel monastero di Santa Rosa insieme ad altre 17 persone ospitate dalla Caritas attraverso la diocesi.
«È stata un’accoglienza perfetta: in pochi giorni ci hanno aiutato per le vaccinazioni anti Covid e per la richiesta del permesso di soggiorno per protezione temporanea», racconta la ragazza in un perfetto italiano. «Spesso – prosegue – mi sentivo in posizione privilegiata perché parlavo già la lingua, così ho aiutato le mie connazionali a spiegarsi in varie situazioni, dalla visita medica alla richiesta del documento. Una volta ottenuto il permesso temporaneo, a maggio, mi sono spostata a Como, che era la mia destinazione, e oggi ho una casa tutta per me. Mi è stata data in prestito dai miei amici italiani, non la utilizzavano da tempo e hanno deciso di fare questo gesto solidale e per me bellissimo. Devo dire che dall’inizio ho sentito intorno a me un’incredibile vicinanza. Ho tanti amici rimasti in Ucraina, molti sono ormai sfollati interni. Mio fratello è nell’esercito e sta combattendo questa guerra, che penso durerà a lungo. E io mi sento fortunata: oggi ho ripreso una vita normale, sto bene. Sono una profuga fuori dagli standard».

In totale gli Stati membri possono utilizzare complessivamente fino a 9,5 miliardi di euro della quota prevista per il 2022 nel quadro di REACT-EU, uno dei maggiori programmi di investimento pubblico post-pandemia dell’UE, nonché le risorse non assegnate della politica di coesione nell’ambito del periodo di bilancio 2014-2020. Il Consiglio ha inoltre adottato una modifica dei fondi per gli affari interni per il periodo 2014-2020 e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2021-2027, per fornire risorse supplementari all’accoglienza delle persone in fuga dalla guerra. Questo permette agli Stati membri di ricorrere in via d’urgenza ai fondi rimanenti per contribuire a far fronte all’afflusso massiccio di persone. E cerca di farlo ancora di più con l’iniziativa FAST-CARE, che la Commissione Ue ha presentato a fine giugno.

«Fino ad ora, l’accoglienza dei profughi dall’Ucraina a livello italiano ha mostrato alcuni elementi di novità. I rifugiati sono liberi di muoversi e vengono sostenuti se trovano sistemazioni autonome, anche tramite la numerosa comunità ucraina già presente nel nostro paese. Il terzo settore, che già svolgeva un grande ruolo nell’accoglienza sui territori, spesso con tante buone pratiche, è stato coinvolto in maniera maggiore e ancora più responsabilizzato. L’accoglienza in famiglia è stata istituzionalizzata», spiega Orlando De Gregorio, ricercatore del Laboratorio Percorsi di secondo welfare. «Questi – continua il ricercatore – sono elementi che andrebbero resi strutturali e messi a disposizione dell’intero sistema, per farlo crescere in qualità e quantità. Ciò che però potrebbe far davvero la differenza sarebbe un aumento significativo dei posti nella rete Sai a discapito di quelli nei Centri di accoglienza straordinaria (Cas). Lo ha chiesto in più occasioni anche Matteo Biffoni, sindaco di Prato e delegato Anci per l’immigrazione.
Se, infatti, per i rifugiati ucraini si parla di un modello straordinario che ha consentito non solo la libertà di movimento (gli ucraini non necessitano già dal 2017 di visto in Ue) ma anche il superamento nei fatti del Regolamento Dublino, altrettanto non si può dire per altri casi. Nella stessa applicazione della direttiva 55/2001 si è deciso di fare distinzione tra le persone in fuga: sono ammesse alla protezione temporanea, infatti, solo i cittadini ucraini, le persone che in Ucraina avevano un permesso di soggiorno di lungo periodo e i titolari di protezione internazionale. La decisione ha fatto molto discutere perché tiene fuori sia i migranti stagionali sia i tanti studenti stranieri che vivevano nel paese con un visto di studio di breve periodo. È il caso di Hilary Ikengwon, 24 anni, che dalla Nigeria era andato a Charkiv, nell’Est dell’Ucraina, per studiare medicina. «Mi sono ritrovato nel mezzo di un conflitto senza neanche capire bene cosa stava succedendo, ero arrivato da pochi mesi», racconta. «Sono scappato via il prima possibile e ho viaggiato verso il confine più vicino, la Polonia. Ricordo dieci ore di fila per varcare la frontiera, la polizia dava la precedenza a donne e bambini, noi dovevamo aspettare», aggiunge. Anche Ikengwon è arrivato in Italia a bordo di un volo umanitario e ora vive ad Assisi, accolto dalla Caritas italiana.
«Non posso avere il permesso temporaneo come gli ucraini, per questo sto facendo tutto l’iter di richiesta per avere un documento. L’associazione mi sta aiutando. Quello che voglio è solo tornare a studiare, vorrei iscrivermi all’università qui in Italia, dove so che gli standard di formazione sono altissimi ma mi hanno spiegato che i tempi di attesa possono essere lunghissimi», spiega.
A marzo diverse testate e organizzazioni che lavorano sulla tutela di migranti e rifugiati hanno denunciato respingimenti al confine tra Polonia e Ucraina delle persone con la pelle scura. Ugualmente, agli altri confini dell’Unione Europea, negli ultimi mesi permane l’atteggiamento di chiusura nei confronti degli altri migranti forzati provenienti da zone di conflitto o aree di crisi, che continuano a rimare bloccati alle frontiere. O peggio. Come nel caso dell’ultima strage a Melilla, la piccola enclave spagnola in Marocco, dove lo scorso 27 giugno, almeno 37 persone sono morte nel tentativo di passare la frontiera.

Bilal*, 23 anni, è originario del Badakhsan, una provincia orientale dell’Afghanistan. Si era arruolato nell’esercito qualche mese prima della caduta di Kabul per il ritorno dei talebani, lo scorso agosto. Mentre lo racconta, seduto su una sedia nel giardino del rifugio Fraternità Massi, a Oulx in Val Di Susa, mostra tre tagli sul braccio e delle cicatrici sul collo. «Queste ferite me le hanno fatte loro [i talebani, ndr] perché mi consideravano un collaboratore del governo. Mi hanno preso e picchiato, sono riuscito a scappare miracolosamente. Ma da quando sono tornati i talebani la mia vita era in costante pericolo. In pochi giorni è cambiato tutto – racconta -. Non ho avuto altra scelta che andare via». A fine agosto del 2021 Bilal ha lasciato l’Afghanistan per passare il confine con il Pakistan. «È stato un viaggio pericolosissimo, se fossi stato scoperto e rimandato indietro mi avrebbero di sicuro ucciso. Mi sono affidato ai trafficanti e sono riuscito ad arrivare in Turchia». Da qui, con un’imbarcazione, il suo viaggio prosegue verso la Calabria e poi in treno fino in Piemonte, in questa cittadina a pochi chilometri dalla Francia. E da quel confine che Bilal ha provato a passare due volte attraverso la montagna. «I gendarmi mi hanno respinto violentemente, è stato inutile dire che vengo dall’Afghanistan e sto scappando da una morte sicura per mano dei talebani. Il marito di mia sorella è stato ucciso nel marzo scorso, se dovessi essere rimandato indietro il prossimo sarei io».

Secondo Medici per i diritti umani (Medu) che opera nel rifugio di Oulx insieme ad altre organizzazioni, dall’inizio del 2022 sono oltre mille le persone respinte dalla Francia all’Italia: 669 al Monginevro e 344 al Frejus. In totale, fino ad aprile al rifugio si sono registrati 1.814 arrivi, tra cui 66 famiglie e 132 minori stranieri non accompagnati, a fronte di 2.116 partenze (il numero è superiore agli arrivi perché alcune persone vengono respinte alla frontiera e tornano al rifugio per poi tentare nuovamente l’attraversamento). La maggior parte delle persone che arrivano qui per provare a passare il confine sono afghane, ma ci sono anche iraniani e curdi di diverse nazionalità. Numerose sono le famiglie con bambini, spesso neonati, anche se non sempre accompagnati da tutti i genitori. Non è raro neanche vedere la presenza di persone provenienti dal Maghreb, in maggioranza uomini, che hanno scelto la via più lunga per sfuggire alle violenze libiche e alla traversata nel Mediterraneo: molto spesso, infatti, chi arriva a Oulx ha alle spalle un viaggio lungo la rotta balcanica, che significa ripetuti respingimenti, anche con violenze e maltrattamenti, nel tentativo di passare quello che chiamano il “game”, il superamento delle frontiere ai confini dell’Ue.
Fayra, 40 anni, arriva dal Libano. Ha gli occhi grandi, il sorriso gentile e uno sguardo che tradisce la fatica degli ultimi mesi. Per sette anni la sua famiglia ha vissuto in Svezia. «Siamo andati via dal nostro paese perché mio marito è un oppositore politico», spiega. «Era stato minacciato di morte dopo un comizio e abbiamo deciso di partire. Fino a poco tempo fa la nostra era una vita normale, felice», dice. In Svezia i suoi tre bambini, Omar, Yehua e Hamad frequentavano la scuola. La più piccola, sorda dalla nascita, aveva iniziato anche un corso in lingua dei segni. «Ma durante la pandemia mio marito ha perso il lavoro e non siamo più riusciti a rinnovare il permesso di soggiorno. Da un giorno a un altro siamo caduti in un incubo, col terrore di essere rimpatriati in Libano. Così siamo venuti in Italia, a Roma, dove eravamo riusciti ad ottenere accoglienza. Poi con la crisi ucraina, per far posto ai nuovi rifugiati, ci hanno detto che dovevano separarci in due strutture: io e i bambini in una casa rifugio per donne al centro, mio marito in un centro di accoglienza fuori dalla città. Non riuscivamo a vivere così e abbiamo deciso di ripartire».
Secondo una recente denuncia di Save the children anche i minori non accompagnati continuano a essere sistematicamente respinti alle sia alle frontiere esterne dell’Ue, sia a quelle interne tra stati membri, come Francia e Italia. Secondo l’organizzazione quella che si sta delineando è ormai un’Europa a due livelli: «i suoi paesi dimostrano di saper spalancare le braccia e le porte alla popolazione in fuga dalla guerra in Ucraina, ma al contempo si dimostrano brutali e disposti a usare forza ingiustificata contro gente inerme, “colpevole” di non avere documenti validi per l’ingresso, ma bisognosa allo stesso modo di un posto sicuro».

Questa situazione è ciò che gli esperti chiamano ormai da mesi un doppio standard di protezione e accoglienza: un sistema binario che rischia di creare spiacevoli distinzioni tra profughi di serie A e profughi di serie B. «Va benissimo la risposta messa in campo per i rifugiati ucraini. L’applicazione della direttiva 55/2001 è stata importante ma negli anni, pur in situazioni simili, non abbiamo visto lo stesso, come nel 2015 con la crisi siriana», sottolinea Sara Prestianni, responsabile dei programmi immigrazione e asilo per EuroMed Rights. «Non può esserci – prosegue – una gestione differenziata dell’accoglienza in funzione dell’origine delle persone. L’esempio più eclatante è quello della Polonia, che prima dello scoppio della guerra in Ucraina ha respinto e lasciato morire poche centinaia di persone al confine con la Bielorussia per poi accogliere senza problemi oltre tre milioni di profughi dall’Ucraina». Secondo la referente di Euromed Rights la situazione potrà diventare ancora più paradossale nei prossimi mesi: «La guerra sta mettendo a rischio la sicurezza alimentare di alcuni paesi, come Libano, Tunisia ed Egitto, accentuandone la crisi economica e democratica. In questo caso la risposta degli stati europei è stata quella di lanciare un’allerta su un possibile aumento dei flussi migratori», continua Prestianni. «La ministra dell’Interno italiana Luciana Lamorgese – prosegue – ha organizzato un vertice a Venezia con i ministri della sponda sud del Mediterraneo. Si è parlato di accelerare un meccanismo di solidarietà, che però è stato tradotto nel Consiglio per gli affari interni in un’opzione tra redistribuzione ed esternalizzazione delle frontiere, combinato con un approccio hotspot rafforzato.
Allo stesso tempo il commissario europeo per l’allargamento e la politica di vicinato Olivér Várhelyi, in visita in Egitto, ha promesso cento milioni di euro per la sicurezza alimentare e 80 milioni per il rafforzamento delle frontiere. Anziché parlare di cooperazione allo sviluppo si cerca ancora una volta di bloccare le persone ai confini».

Per alcuni, l’apertura. Per altri, la chiusura. Una differenza che appare oggi con ancora più evidenza guardando a quello che accade nella frontiera italiana più a Sud, nell’isola simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo: Lampedusa. Una volta celebrata come porta d’Europa, ora è l’esempio del fallimento di una gestione coordinata e solidale dell’accoglienza. Come ogni estate, con il mare calmo e le condizioni marine favorevoli, tornano ad aumentare gli arrivi e con essi le criticità di un sistema senza una reale governance. In totale, da gennaio al 21 giugno sono stati 24.774 gli arrivi via mare in Italia, di questi circa diecimila hanno riguardato la piccola isola a sud della Sicilia. Qui, oltre mille persone sono arrivate solo nelle prime due settimane di giugno, insieme ai turisti che sono tornati ad atterrare sull’isola con la ripresa dei voli diretti operati dalle compagnie low cost. Ma se i vacanzieri affollano le spiagge e i luoghi del divertimento, quella dei migranti è una presenza invisibile: una volta sbarcati vengono portati nell’hotspot di contrada Imbriacola, una struttura chiusa alla fine di una strada sterrata, lontana dal centro abitato. E perennemente sovraffollata: il centro, mai ristrutturato dopo un incendio, potrebbe ospitare un massimo di 250 persone ma spesso se ne contano anche mille. «Con la pandemia la situazione è cambiata, prima c’era una maggiore flessibilità, mentre ora i migranti non sono liberi di uscire dal centro. Restano anche per lunghi periodi dentro gli spazi chiusi e sovraffollati dell’hotspot», spiega Marta Barabino, operatrice di Mediterranean Hope, il programma migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia. «Paradossalmente – prosegue – durante l’emergenza sanitaria da Covid 19 le persone sbarcate dovevano fare il periodo di isolamento preventivo sulle navi quarantena e la gestione dell’accoglienza era più semplice: i trasferimenti erano veloci per la paura che il virus si diffondesse sull’isola. E la struttura veniva periodicamente svuotata. Ora che le navi quarantena hanno perso questa funzione non capiamo perché non possano essere utilizzate per trasferire le persone in tempi rapidi sulla terraferma e consentire un’accoglienza adeguata e dignitosa».
Questa storia di malaccoglienza, che si ripete ormai da anni non stupisce Giusi Nicolini, che a Lampedusa è stata sindaca dal 2012 al 2017. «L’emergenza qui non è nei numeri, ma umanitaria ed è legata alla mancanza di volontà politica di accogliere le persone», spiega. «L’istituzione dell’hotspot di Lampedusa ne è l’esempio più lampante: è nato con l’idea di selezionare le persone, dividendole al primo arrivo. Qui un muro fisico non si può erigere, però questo hanno fatto. Ed è coerente con la logica di chiusura che massacra chi arriva e le comunità ospitanti: è la differenza tra avere sul territorio un luogo aperto o uno chiuso, cioè tra avere un carcere o un centro di accoglienza. E questo è chiaramente in linea con una politica, italiana ed europea, tesa ad escludere Fino all’istituzione dell’hotspot, anche grazie alle battaglie che negli anni abbiamo fatto, nel centro si poteva entrare, io ho fatto anche diverse iniziative all’interno. Ora invece è impossibile», spiega. «In questi anni – conclude Nicolini – non è cambiato nulla, anzi oggi stiamo tornando indietro. Si è perso anche l’afflato emotivo per il naufragio del 3 ottobre 2013, in cui persero la vita 368 persone, proprio qui, davanti a queste coste».
Dal campo, il racconto del doppio standard di accoglienza dei profughi ucraini in Europa.
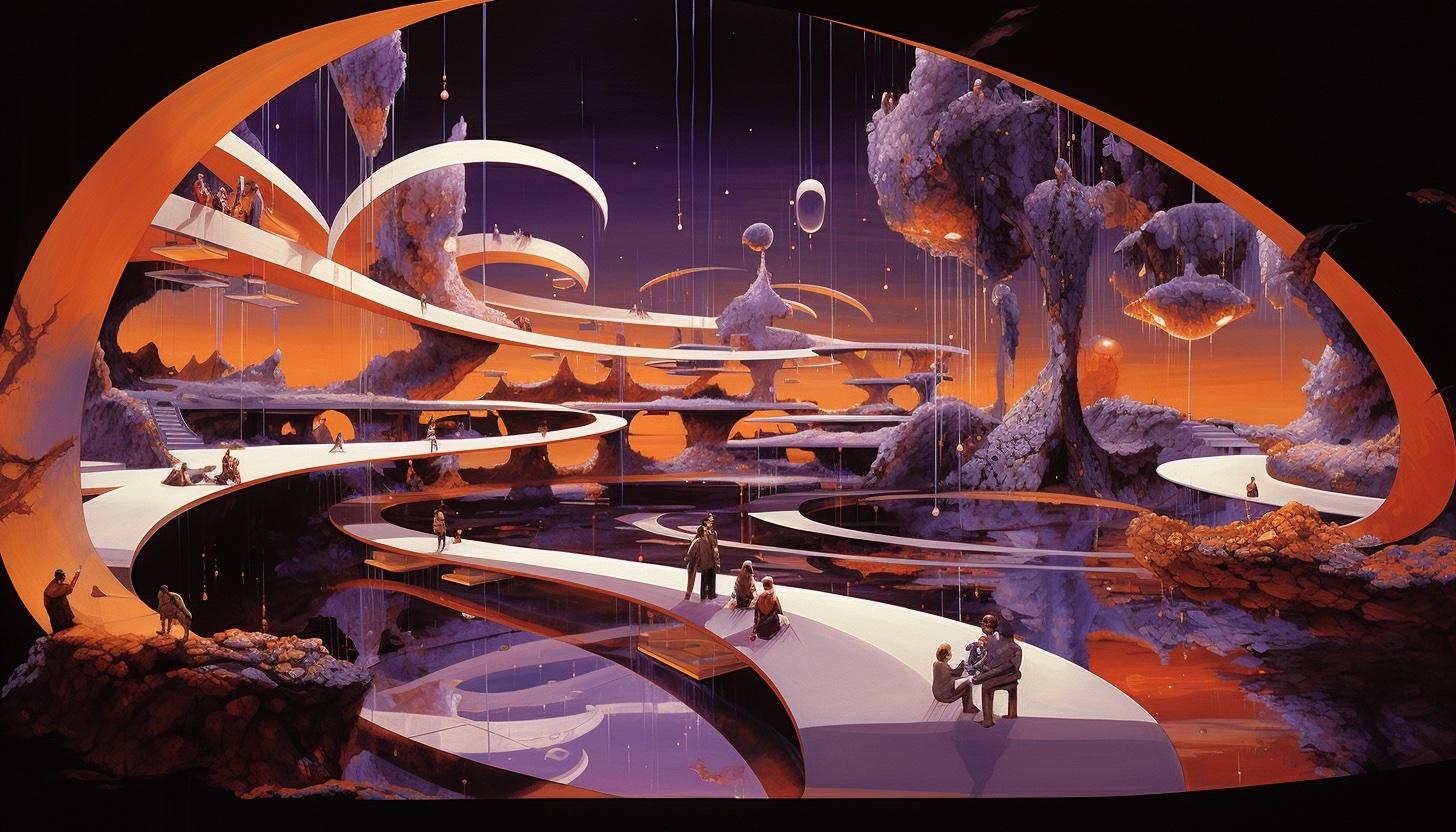
La storia di Aliona Fedchyshyna: «Così ho aiutato gli altri profughi ucraini in Italia, prima di tornare a casa».
La storia di Aliona Fedchyshyna: «Così ho aiutato gli altri profughi ucraini in Italia, prima di tornare a casa».
A oltre un anno e mezzo dall’inizio della guerra, un’analisi di come le persone le persone in fuga dall’invasione russa sono state accolte dagli stati europei
Le persone, nel mondo, si spostano per tante ragioni. Quelle legate alla crisi climatica sono sempre più importanti. Eppure, in Europa non vengono prese in considerazione e così la migrazione finisce per essere considerata un’emergenza, ma per le ragioni sbagliate
Nel Lazio, un progetto sostenuto dai fondi di coesione UE ha aiutato Hanna, Kateryna e Larysa ad avere un’occupazione. A livello continentale, però, le loro sono eccezioni.
Senza le testimonianze collettive ci manca un pezzo fondamentale per smascherare le narrazioni del potere.
Esperienze dalla Repubblica Ceca e dalla Romania mostrano che la desegregazione funziona: dove si insegna insieme, tutta la società cresce.
Finanziamenti europei, dati incompleti e progetti “dal basso”: tra numeri e volti, la difficile inclusione dei bambini Rom a Roma.
Tra sgomberi, stereotipi e propaganda, la comunità Rom resta il bersaglio preferito della politica e dei media italiani